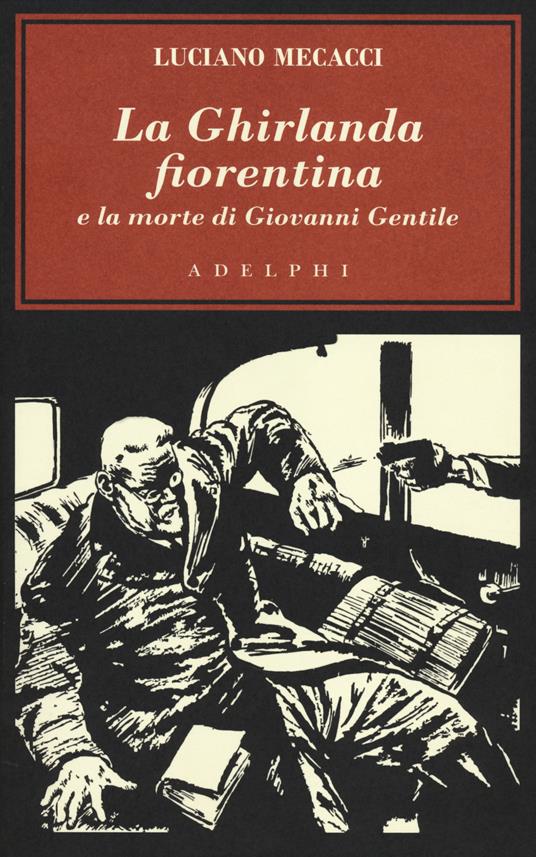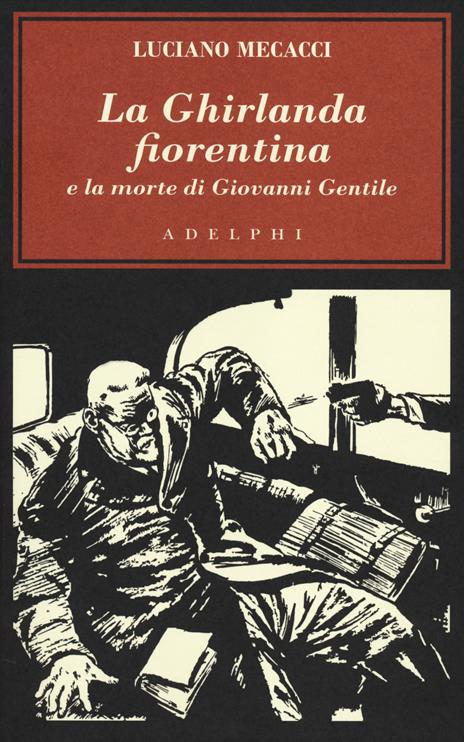L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
La Ghirlanda fiorentina e la morte di Giovanni Gentile
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Prezzo minimo ultimi 30 giorni: 27,20 €
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori













Tutti i formati ed edizioni
"Sono cose che ancora non si possono dire". Questa affermazione di Cesare Luporini, una delle teste pensanti del PCI nel secondo dopoguerra, risale a un'intervista radiofonica sull'"affaire Gentile" rilasciata nel 1989, a quasi cinquant'anni di distanza dai fatti. Bene, chi vive in Italia è abituato a delitti politici preparati, eseguiti e poi coperti in un'atmosfera acquitrinosa, dove nessuno per certo è innocente, ma un colpevole sicuro non esiste. Eppure, l'assassinio di Giovanni Gentile in quel freddo aprile del 1944 rimane un cold case diverso da tutti gli altri - che l'indagine di Luciano Mecacci, condotta anche su documenti inediti, riapre in modo clamoroso. Tutto, in questa ricostruzione, è perturbante. I moventi, molto meno limpidi - o molto più umani - di quanto fin qui si è tentato di far credere. La scena del delitto, cioè la Firenze cupa e claustrofobica occupata dai tedeschi. E naturalmente gli attori. Qualcuno ha discusso, deciso, agito: ma come, fino a che punto, perché? Le figure che appaiono sul palcoscenico sono numerose, e molto diverse fra loro. Oscuri gappisti. Feroci poliziotti. Informatori. Doppiogiochisti. E al centro di tutto, il meglio dell'intellighenzia italiana di allora: Luporini, certo, ma anche Eugenio Garin, Antonio Banfi, Mario Manlio Rossi, Guido Calogero, Ranuccio Bianchi Bandinelli, Concetto Marchesi.
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
L'assassinio di Giovanni Gentile un diventa un thriller colto e ben orchestrato. Ben orchestrato dai mandanti ma anche dall'autore che, alla fine, lascia (forse) al lettore la possibilità, o la capacità, o il desiderio, di scoprire i colpevoli, non dell'esecuzione, ma della volontà di fare tacere un maestro diventato scomodo, un paradigma da abbattere, un emblema da eliminare. E' un libro con trama tortuosa, con permanenti richiami su vicende e personaggi; sembra il reticolo delle strade di una città medievale
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

In Italia, quando viene ucciso uno statista o, comunque, una personalità eminente, è quasi inevitabile che l’evento sia seguito da dibattiti inconcludenti, quasi sempre costruiti sulla teoria del complotto. L’assassinio di Giovanni Gentile non è sfuggito a questa tradizione e solo di recente, grazie soprattutto ai lavori di Luciano Canfora (La sentenza, Sellerio 1985), e Paolo Paoletti (Il delitto Gentile, Le Lettere, 2005), è diventato oggetto di una storiografia più equilibrata.
Con il suo poderoso volume Luciano Mecacci aggiunge un’infinità di nuovi elementi al quadro d’assieme e, sebbene anche lui non offra una proposta univoca relativa ai mandanti del delitto, offre tuttavia una serie così vasta di motivi di riflessioni e di conclusioni ineccepibili sulla dinamica dell’uccisione da rappresentare un punto d’arrivo necessario per chiunque voglia riprendere la questione. Il volume si apre con la citazione di un dibattito del 1989 fra Eugenio Garin e Cesare Luporini nel corso del quale Luporini alludeva a “cose che forse ancora non si possono dire, ma molto precise”. Mecacci ha cercato di squarciare il velo di queste espressioni attraversando tre momenti della fine di Gentile: l’atmosfera che precedette la decisione; il modo dell’assassinio; e il problema dei mandanti fiorentini, la “ghirlanda” che spiega ancora certe oscurità e impone una riflessione più vasta. Usa una bella metafora, quella dei cerchi dell’acqua “per cui si parte da un cerchio interno, ristretto a coloro che presero inizialmente la decisione, da cui si irradia il movimento dei cerchi più periferici, fino ad arrivare all’ultimo cerchio, quello dei gappisti, che infine produce l’onda distruttiva”: una metafora che spinge gli esecutori al margine e i mandanti al centro della vicenda poiché, è il parere proposto dalla lettura del libro, Gentile venne ucciso per ciò che rappresentava più che per ciò che era. Vien quasi spontaneo il paragone con Heidegger, il filosofo nazista, sopravvissuto fino al 1976: ma questi era solo un filosofo nazista, mentre Gentile fu il filosofo del fascismo. Si potrebbe anzi dire: lo spirito ideale del fascismo, e in quella sua natura doveva, a parere degli intellettuali che ne vollero la fine, essere cancellato dalla vita e, si pensava, sbagliando drammaticamente, dalla storia. Se egli fosse sopravvissuto, le idee che aveva impersonato sarebbero sopravvissute con lui. Lui estinto, le idee sarebbero scomparse e di esse sarebbe rimasta solo una stanca tradizione affidata agli epigoni. Un’argomentazione politica che non è riuscita né a far dimenticare la tragedia né a far tramontare il pensiero. La non comune accuratezza con la quale Mecacci ha svolto per anni la sua ricerca porta ad alcuni risultati pressoché certi, a ipotesi largamente condivisibili, ma soprattutto induce a una riflessione più generale sulla natura della vita intellettuale fiorentina, che non può non lasciare turbati, soprattutto perché essa è un aspetto pervasivo e durevole di questo mondo.
Sul momento e sulle motivazioni di fondo che portarono all’uccisione di Gentile, Mecacci sostiene con efficacia che l’appropriazione formale della responsabilità da parte del Partito comunista italiano è infondata. Certo, la decisione fu presa da una ristretta cerchia di comunisti fiorentini, tra i quali forse solo Romano Bilenchi manifestò il suo dissenso; ma l’orientamento verso un gesto drammatico non fu solo il frutto della volontà del nucleo comunista fiorentino. Con certosina pazienza, Mecacci mostra come un animus analogo, non partecipe della decisione, ma impregnato del clima che la rese possibile, fu condiviso anche da diversi esponenti del Partito d’Azione, con poche esclusioni, come quella dei Codignola e di Calogero, che non nascosero il loro profondo dissenso. Ma lo scavo sulle fonti (colloqui con i protagonisti o con i loro famigliari, consultazione delle carte d’archivio, revisione della storiografia, collazione delle testimonianze) mostra che contro Gentile esisteva un’ostilità estesa anche agli ambienti più impensabili: da quello dell’oltranzismo neofascista a quello di certi ambienti vicini ai servizi di sicurezza tedeschi, fino al contesto dello spionaggio britannico in Italia. Quanto poi alle ore dell’uccisione, la ricostruzione è più che esauriente: il gruppo era composto da quattro o cinque partigiani; due di questi agirono direttamente, gli altri fecero da staffetta. Bruno Fanciullacci, un vero eroe della lotta antifascista, è stato a lungo considerato come colui che mise in atto la decisione di far fuoco sul filosofo; Mecacci dimostra che se due furono gli autori dell’operazione, chi sparò contro Gentile fu invece Giuseppe Martini, un esponente comunista da principio esaltato, ma poi costretto a esiliare in Francia e in Cecoslovacchia, completamente trascurato e volutamente dimenticato da chi pure gli aveva affidato un compito tanto drammatico.
Il discorso più approfondito riguarda tuttavia la “ghirlanda fiorentina”. Mecacci fa propria, a questo proposito, una definizione proposta da John Purves, un intellettuale scozzese, docente di letteratura Italiana a Edimburgo, ma anche esponente dei servizi segreti britannici in Italia, che affidò a un taccuino dal titolo citato le sue annotazioni sulla vita fiorentina e sugli intellettuali che egli vi incontrò. A dire il vero, gli ambienti di Purves coincidono solo in parte con quelli che Mecacci ricorda nella prima parte del suo volume: i frequentatori di “I Tatti”, la villa che Bernard Berenson possedeva alle pendici di Settignano; o quelli che frequentavano il musicista Igor Markevitch. A questi Purves ne aggiunge molti altri, citando nomi poi divenuti eccelsi nella storia culturale italiana o nomi meno noti, come quello di Mario Manlio Rossi, successore di Purves nell’insegnamento scozzese, o di altre personalità, entrate più o meno direttamente in contatto con i servizi segreti britannici e tali da comporre, con l’originario gruppo hegeliano-neomarxista, il centro propulsore dell’antifascismo fiorentino. Scrive a un certo punto Mecacci dell’esistenza di una intellighenzia fiorentina composta di scrittori, poeti, artisti, e professori universitari, non direttamente schierati nelle file dell’antifascismo comunista. Ma aggiunge che, fatta eccezione per Luporini, “con questo ambiente intellettuale Gentile non entrò mai in contatto diretto, sin da quando si trasferì a Firenze”. Da questo giro “Gentile era distante per lo stile di vita personale e familiare, sobrio e tradizionale”; amava la vita patriarcale ed era fierissimo dei suoi numerosi nipotini. Aveva conservato, insomma, si potrebbe aggiungere, la mentalità dell’intellettuale siciliano e una tipologia poco conviviale. Proprio in questo punto si può scorgere la genesi remota dell’avversione che Gentile incontrò fra gli intellettuali della “ghirlanda fiorentina”.
Occorre tenere presente che nella vita della città era rimasto forte (e rimane forte tuttora) un certo senso della divisione per “arti” dallo stile medievale. E nelle arti si veniva cooptati o da queste si veniva rifiutati. Con il suo distacco, Gentile non aveva fatto nulla per farsi cooptare e questo era il limite della sua influenza cittadina. Per quanto la sua indole privata fosse, come bene spiega Mecacci, bonaria e cordiale, egli non aveva nulla dello stile di vita che lo potesse rendere intrinseco a una delle “arti” fiorentine. Era questa la frattura che alimentava un’ostilità paesana, sino a trasformarla in odio? Si tratta di un’osservazione psicologica esterna alla mera osservazione delle fonti, ma tale da coincidere con la formazione psicologica dell’autore di questo indimenticabile libro.
Ennio Di Nolfo
L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafetyibs@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri