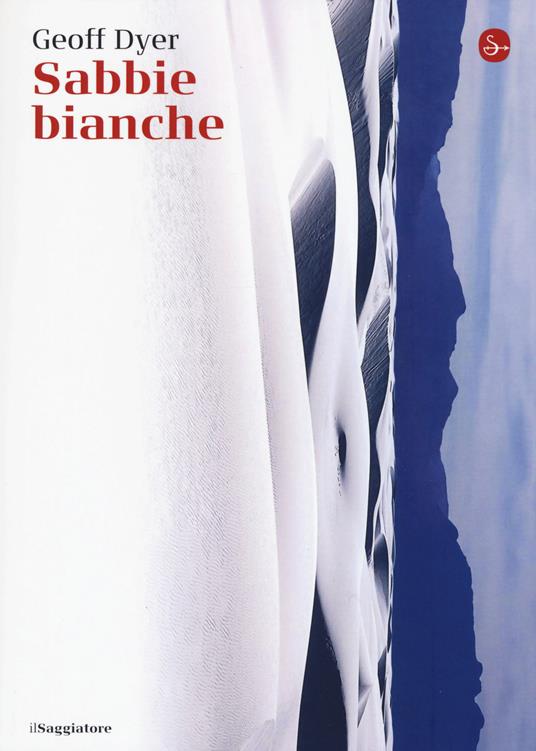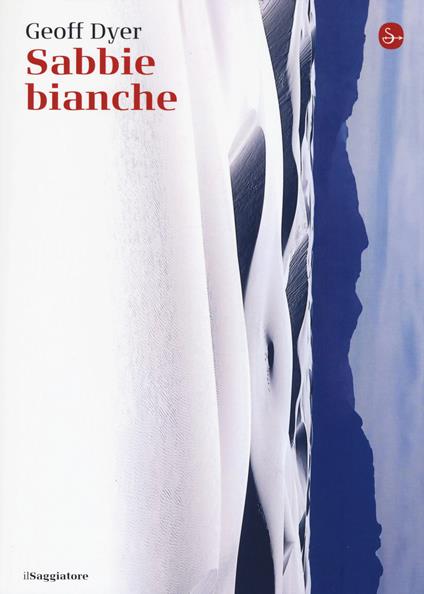L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Sabbie bianche
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori

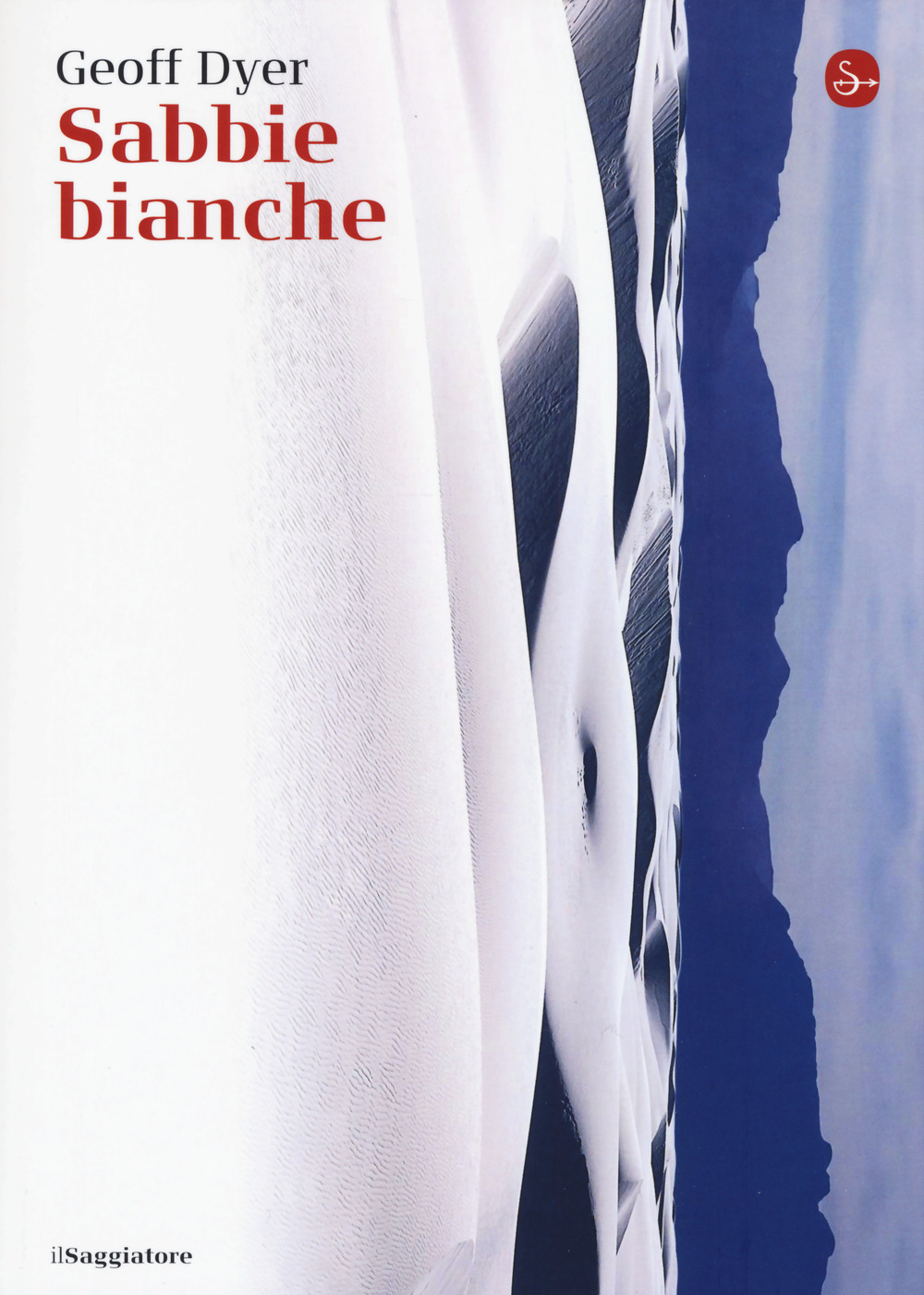
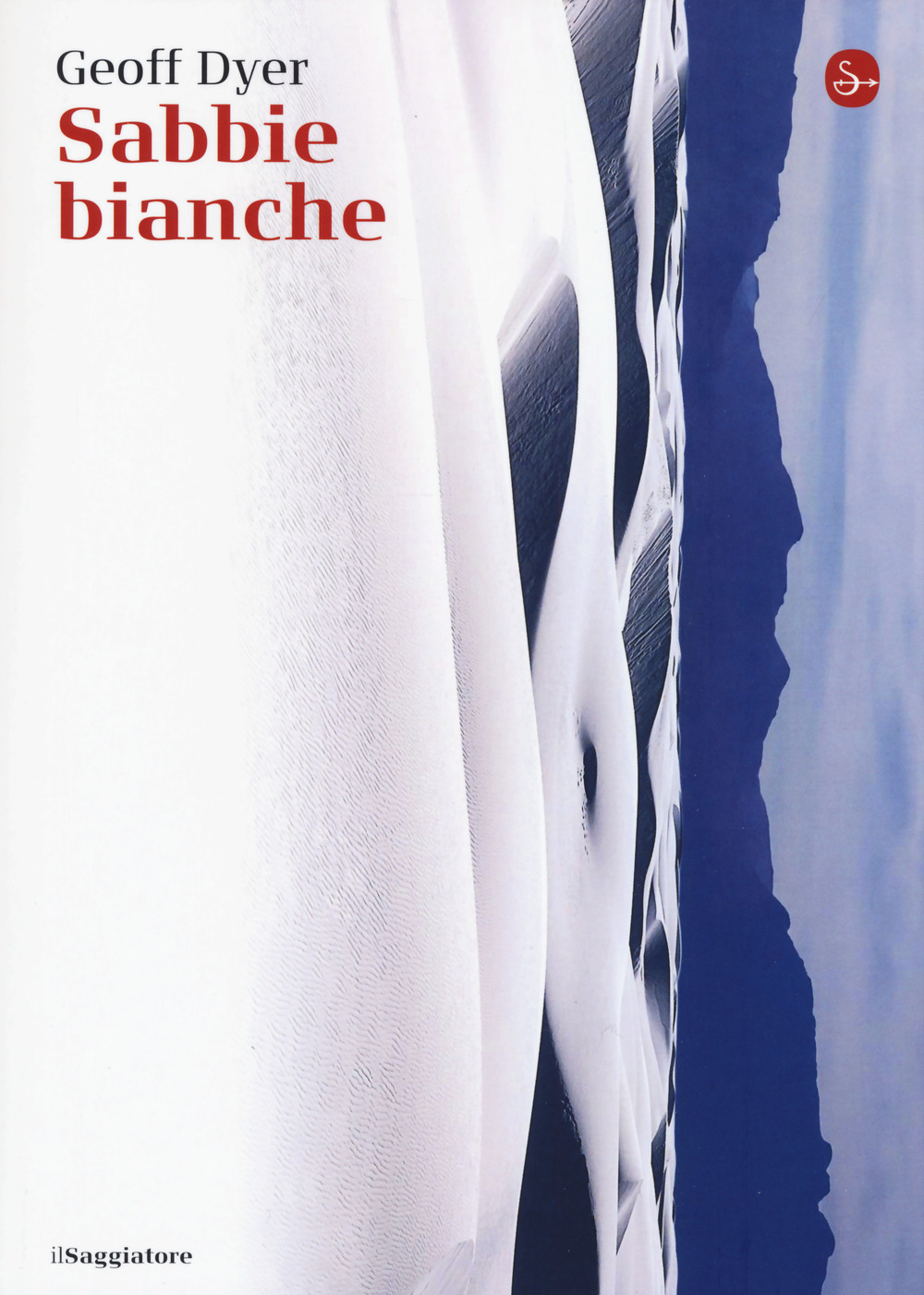
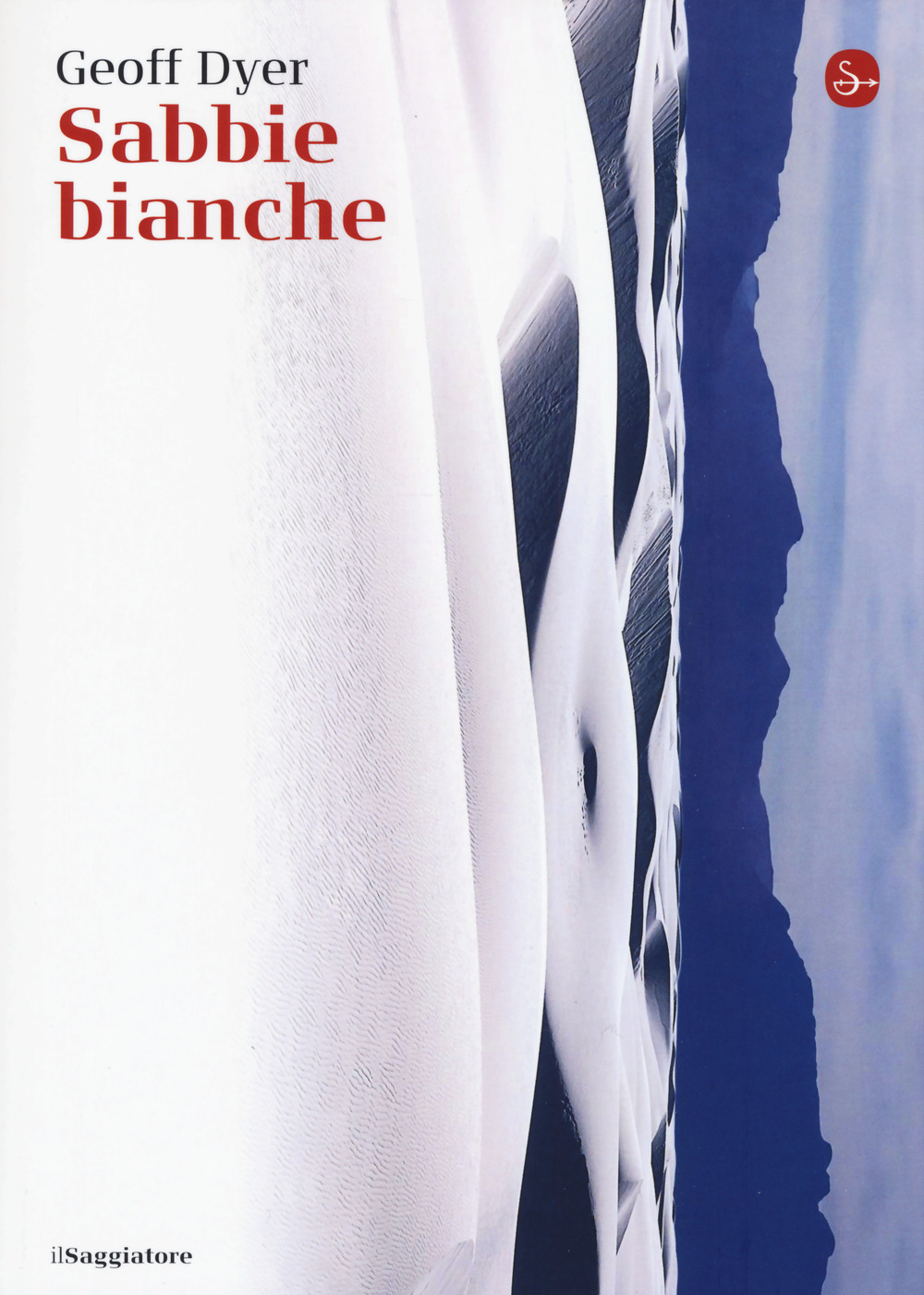
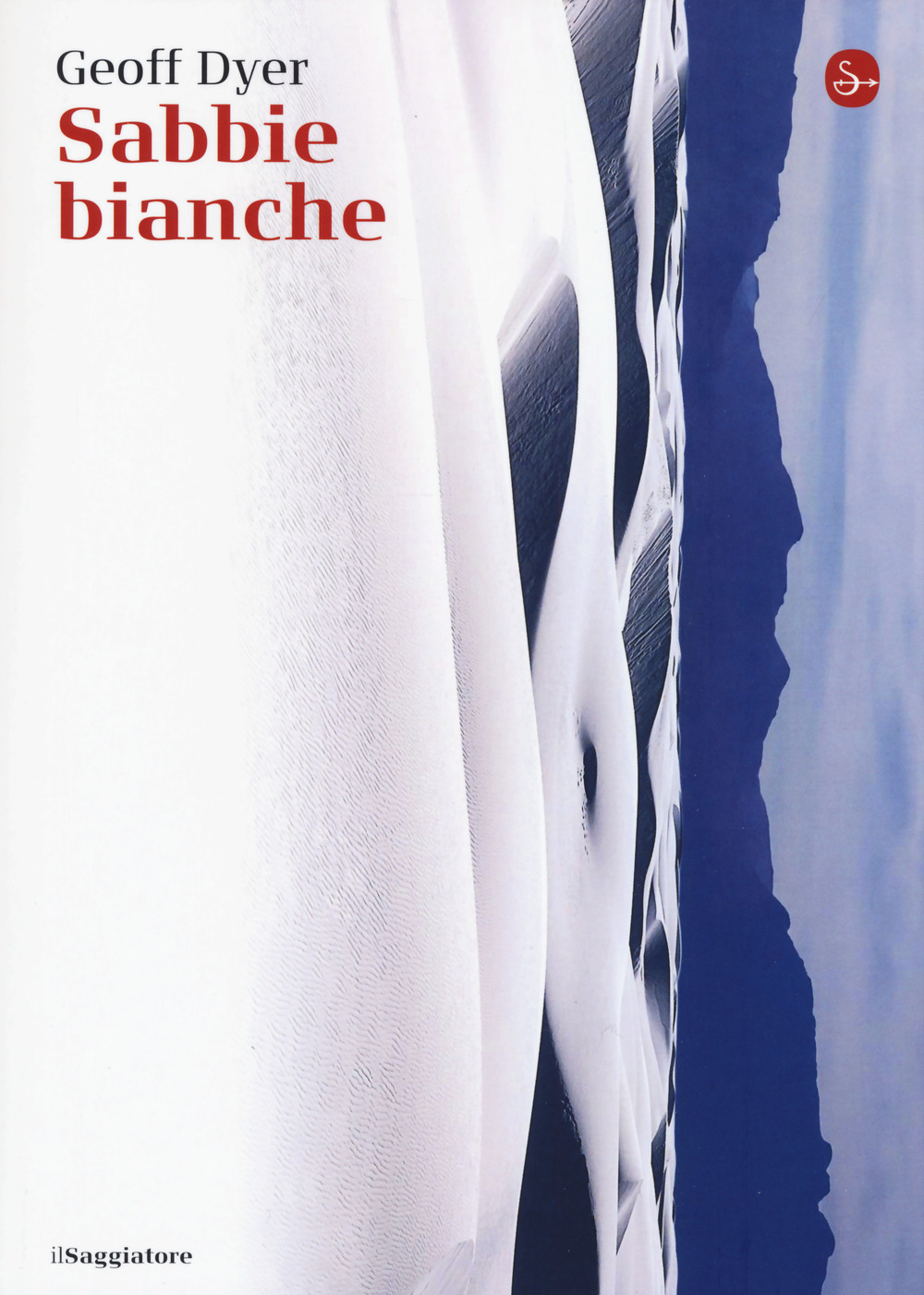
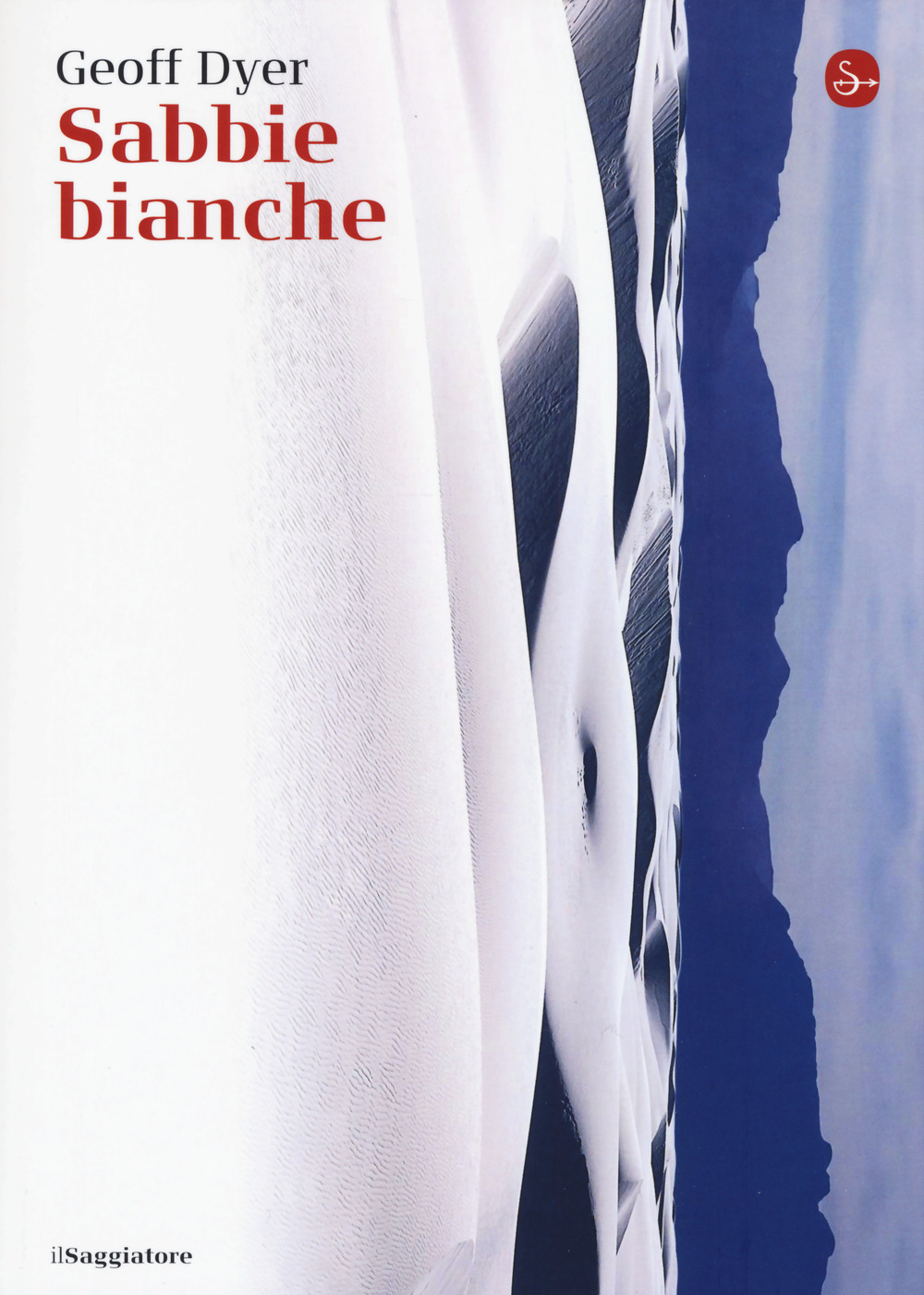
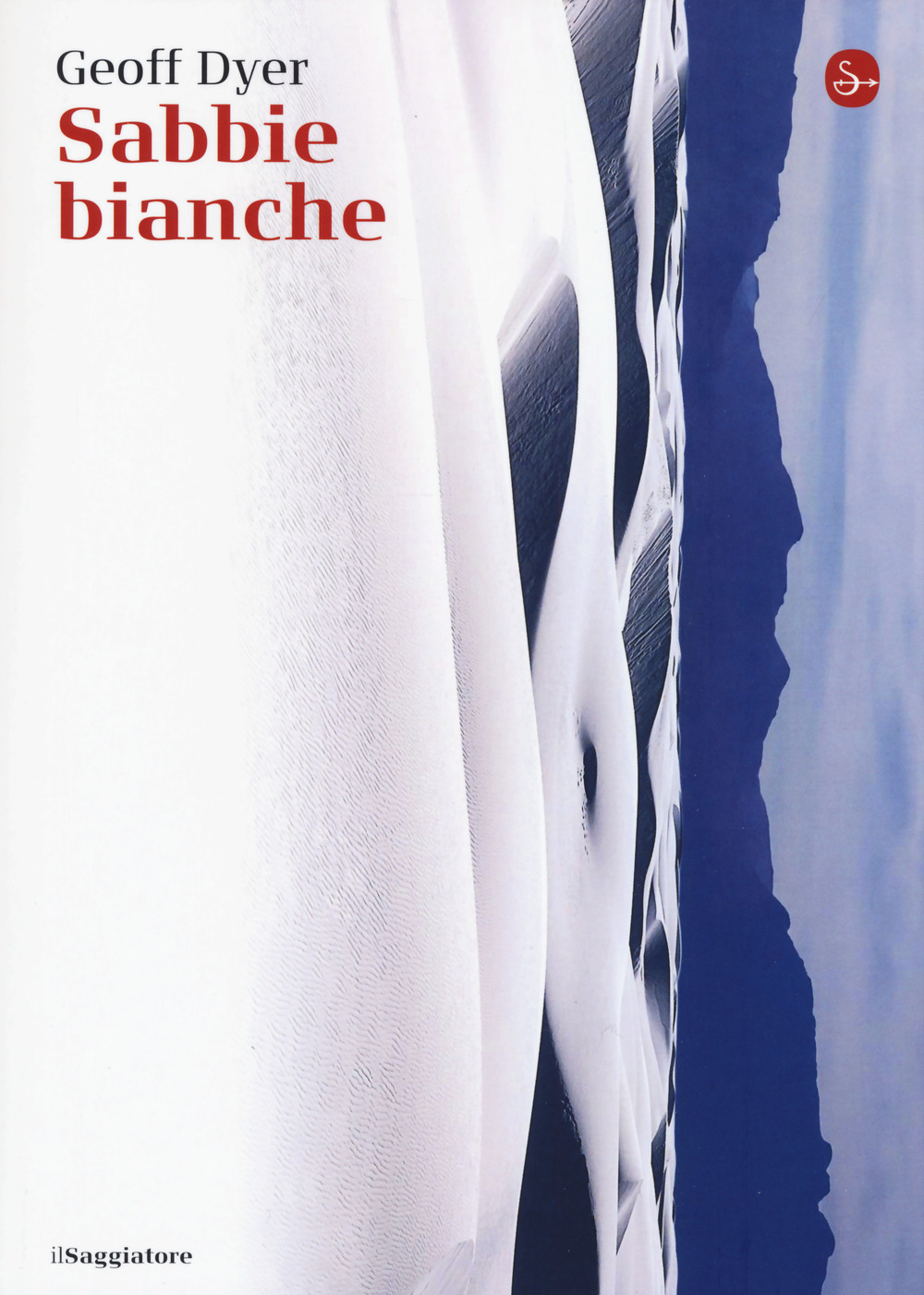
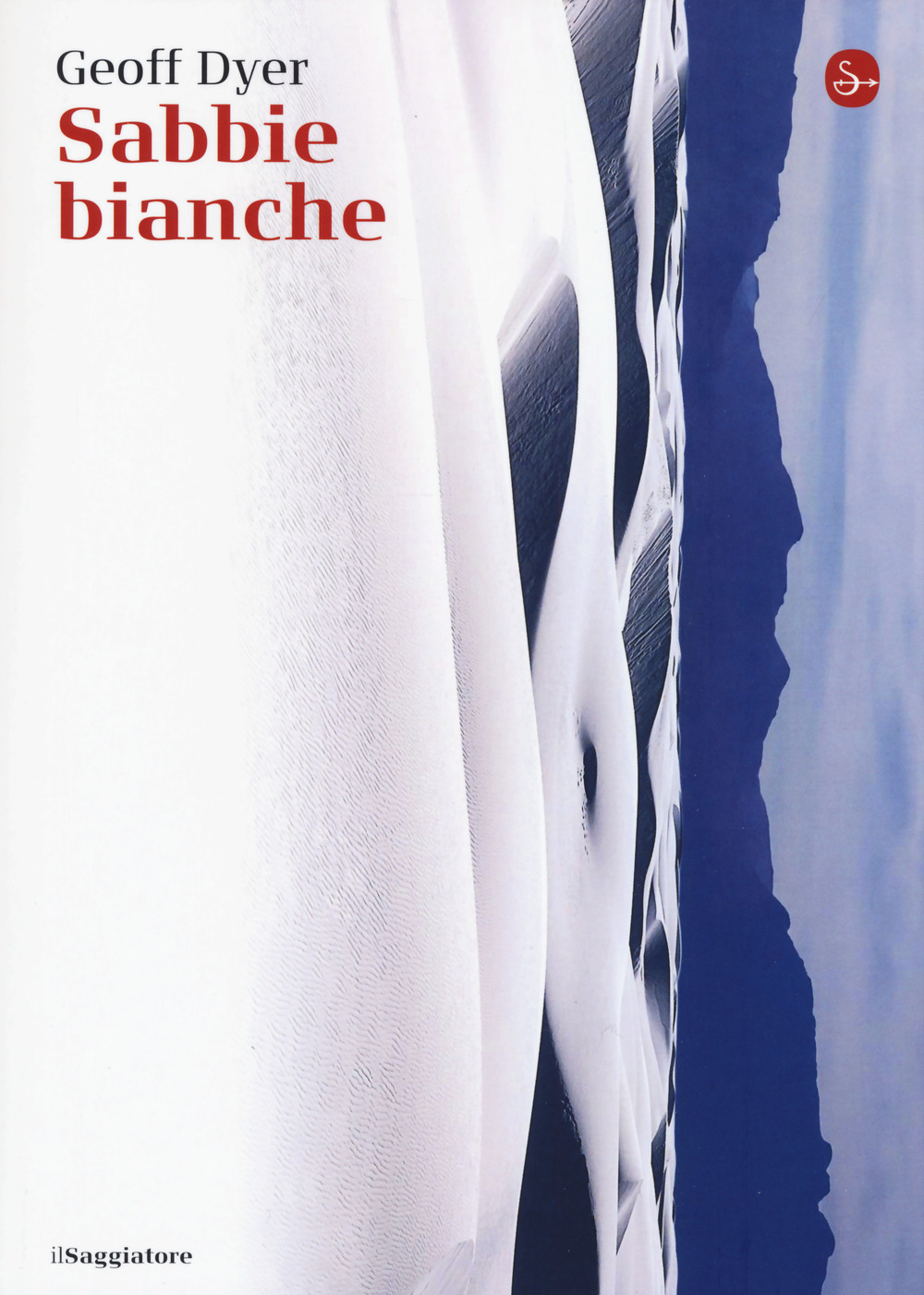
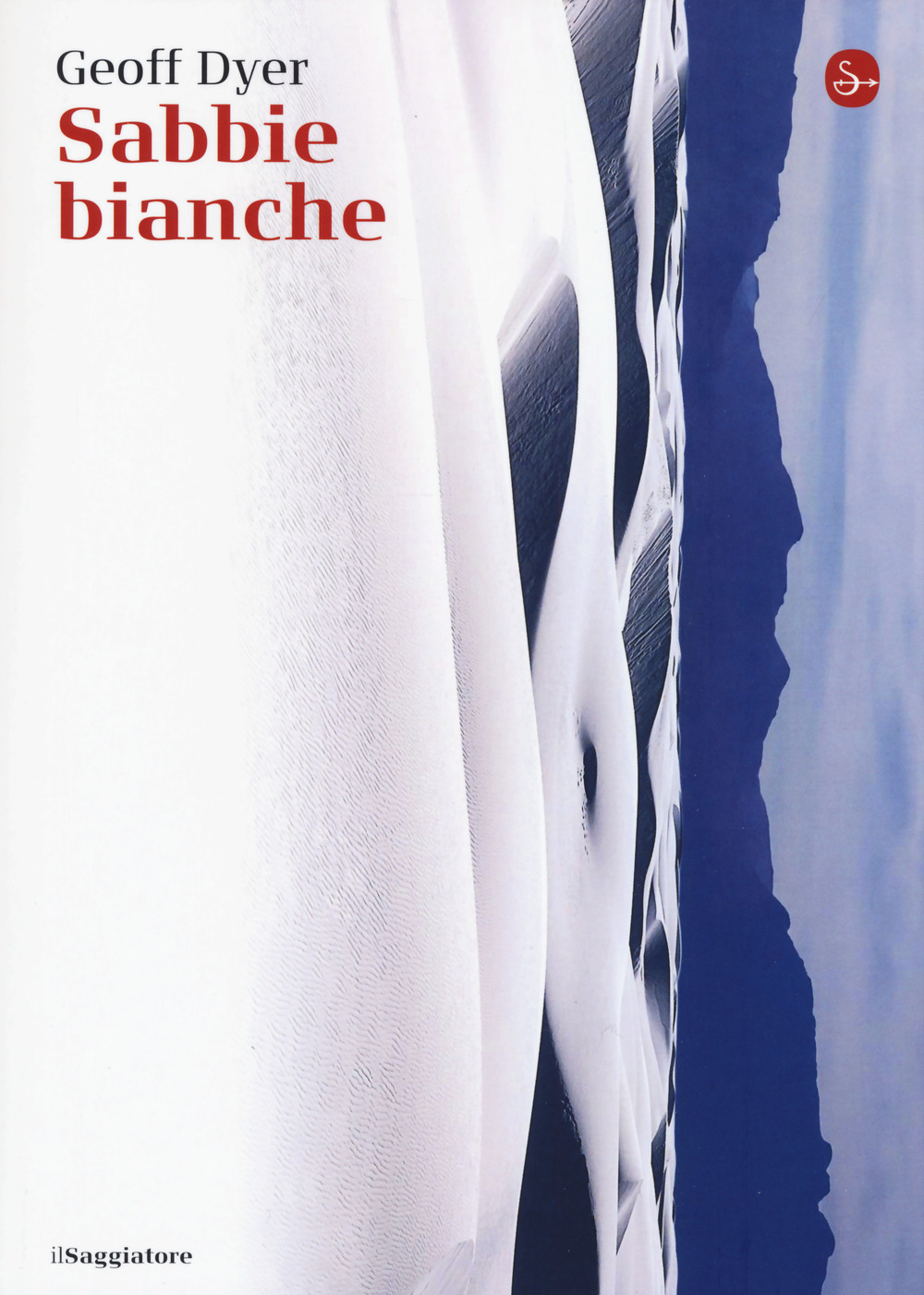
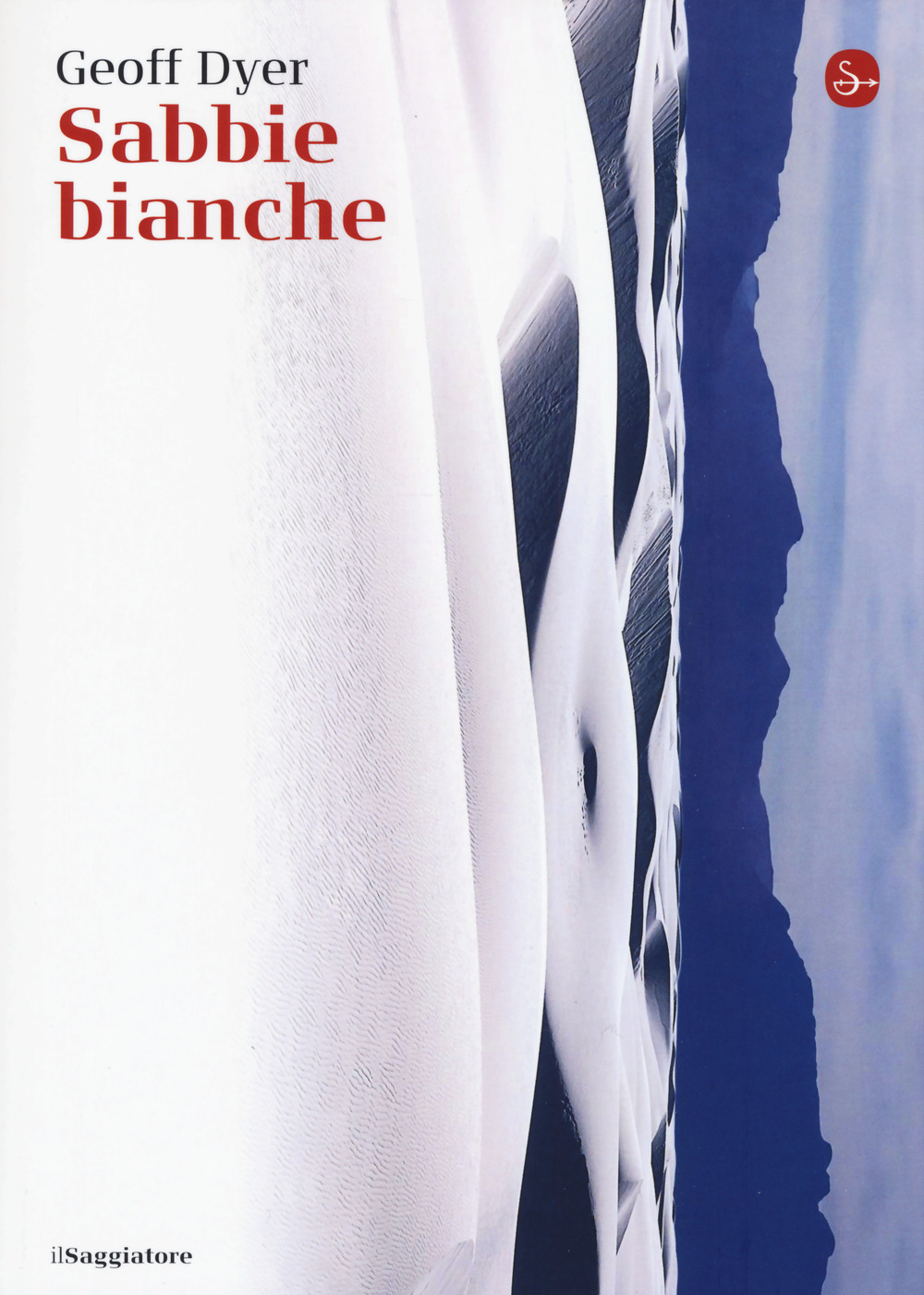
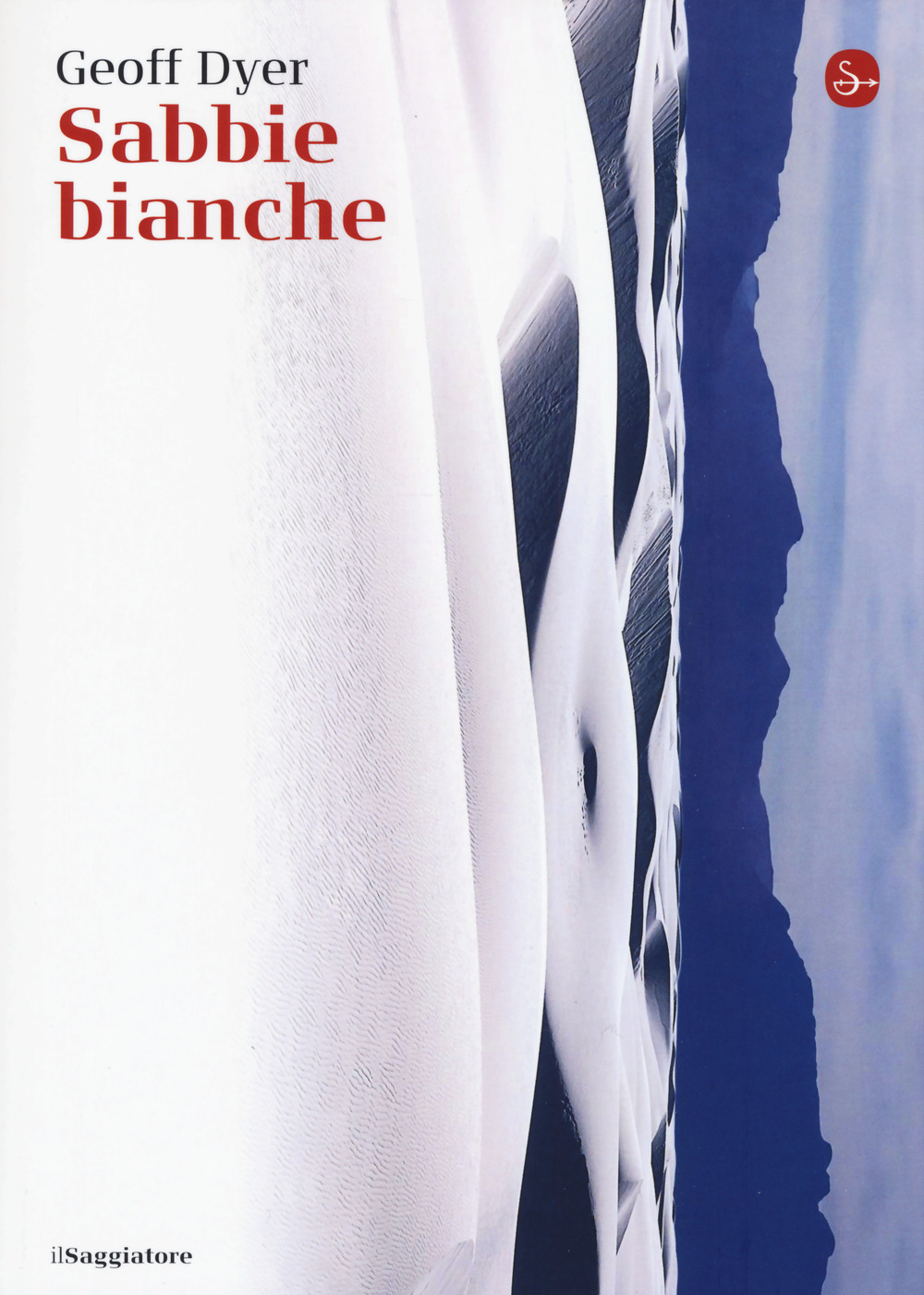
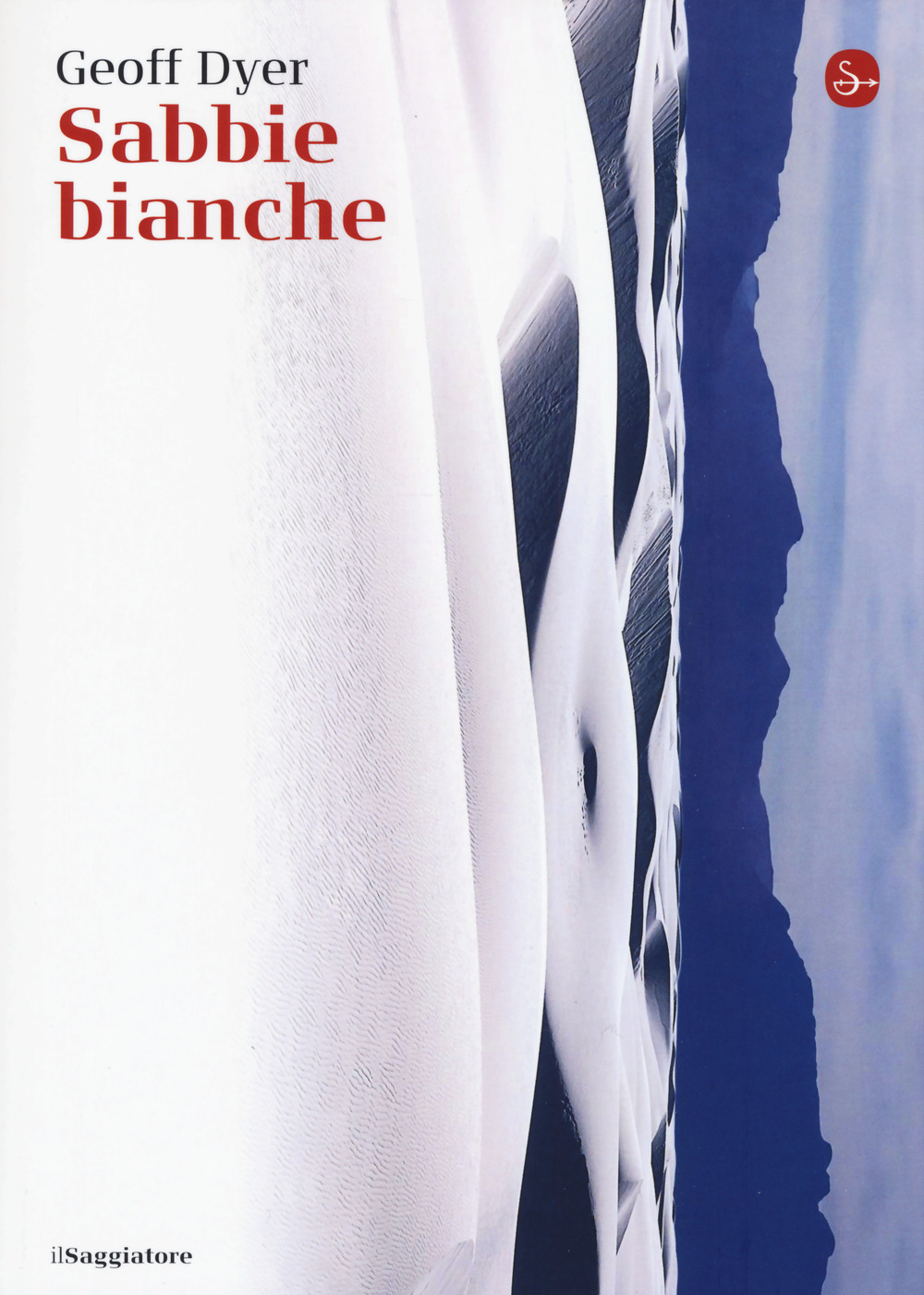
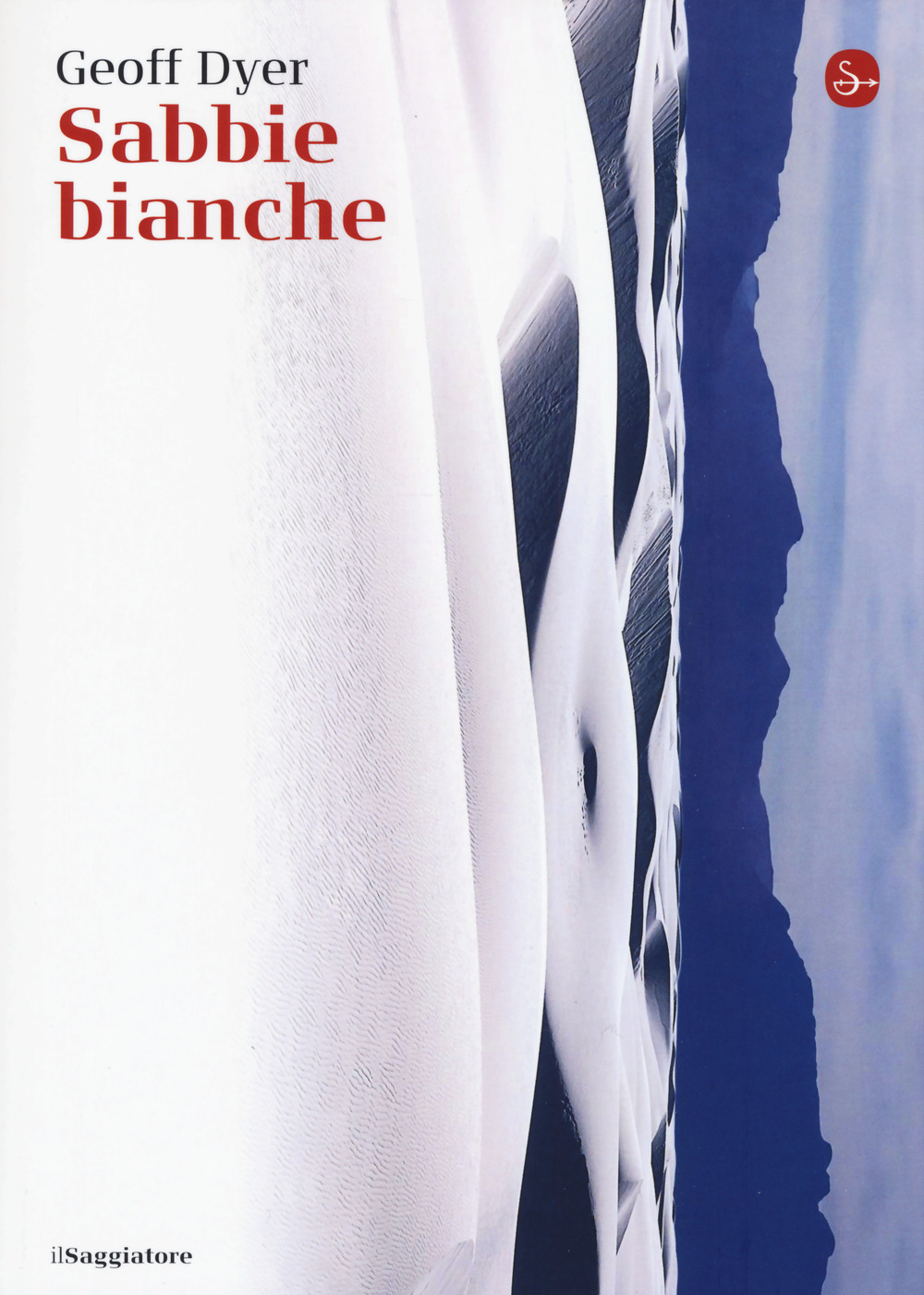
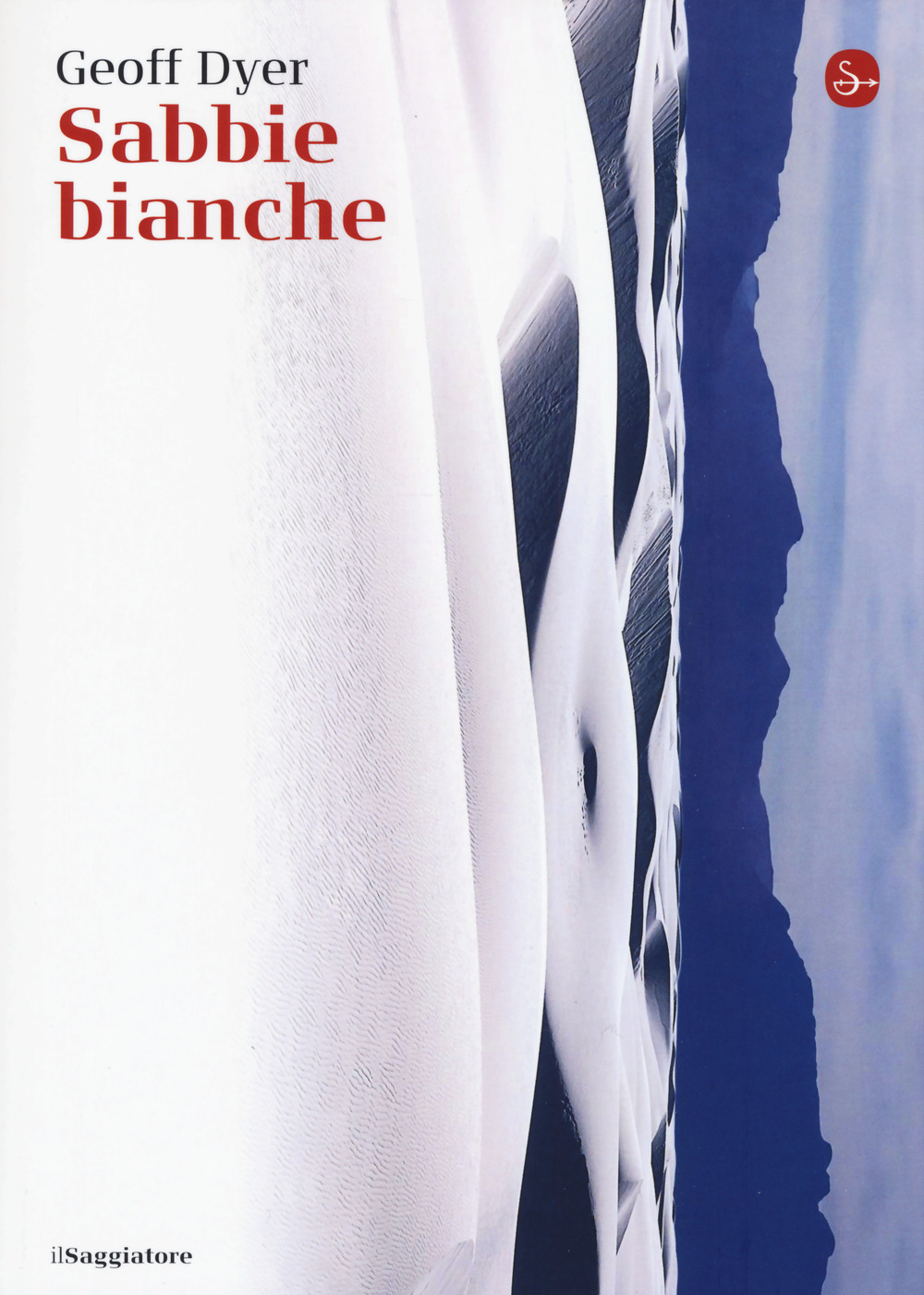
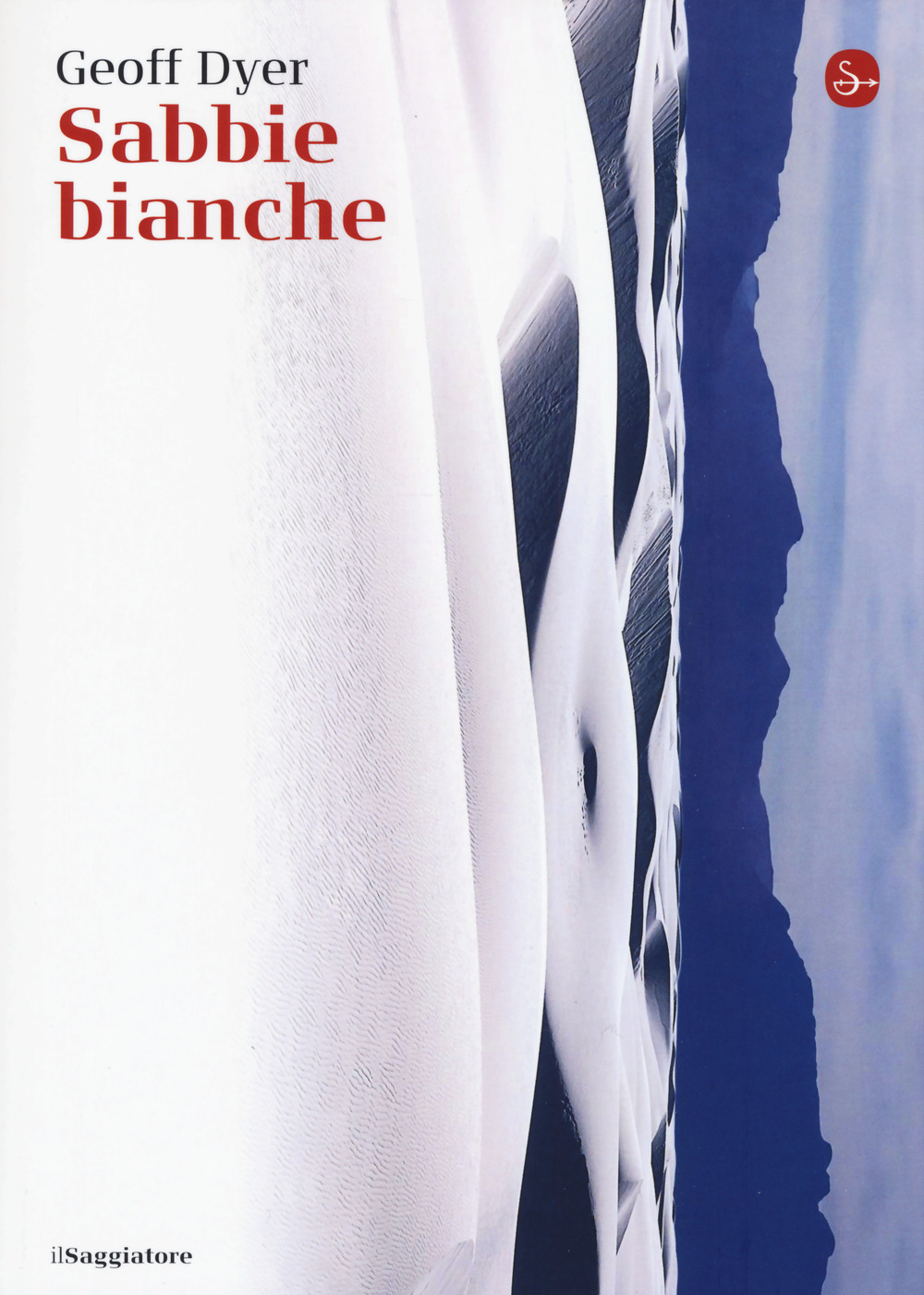
Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2017

Anno edizione: 2017
Promo attive (1)
Sabbie bianche non è un romanzo, né un reportage, non è una raccolta di racconti e nemmeno un diario di viaggio: è tutte queste cose e si ostina a non esserne nessuna; è lo «spazio vuoto sulla cartina» del suo autore. È, soprattutto, la conferma dell'incredibile dono di Geoff Dyer di mescere arte e vita, immagini del reale e fantasmi dell'immaginazione.
Ci sono, nel mondo, città, fiumi, vulcani, deserti che pulsano di un'energia arcana, di un magnetismo misterioso che attrae gli sguardi e i passi, i sogni e i desideri. Ci sono regge, strade, foreste che risuonano di parole: le parole di Goethe quando scorge per la prima volta il mare a Venezia, le parole di Kerouac mentre disegna il profilo dell'America con le ruote di una Cadillac, le parole di Joyce per smarrirsi e ritrovarsi a Dublino, le parole di Hemingway per inseguire il sole da Parigi a Pamplona. Parole che guidano, parole cicerone, calamite, fari: parole che ci fanno vedere il mondo come altrimenti non potremmo mai fare. A queste parole si aggiungono oggi quelle di Geoff Dyer, stralunato viaggiatore, favoleggiatore babelico, flâneur della letteratura, incantatore della sabbia, che sa animare per plasmarla in forme sempre nuove, un ammaliamento che non conosce fine: sabbia bianca dei deserti americani, sabbia bianca fra le strade della Città Proibita, sabbia bianca di neve sotto il cielo di una notte alle Svalbard, sabbia bianca in riva al mare di Tahiti, sabbia sospesa nel vento, sabbia che scorre dalle dita chiuse a pugno, sabbia in perpetuo, inarrestabile movimento. Come Geoff Dyer, come noi. Sabbie bianche non è un romanzo, né un reportage, non è una raccolta di racconti e nemmeno un diario di viaggio: è tutte queste cose e si ostina a non esserne nessuna; è lo «spazio vuoto sulla cartina» del suo autore. È, soprattutto, la conferma dell'incredibile dono di Geoff Dyer di mescere arte e vita, immagini del reale e fantasmi dell'immaginazione: geodeta della parola, Dyer deposita nel deserto abbacinante della pagina i semi di un'affabulazione inesauribile, come inesauribile è la sua e nostra tensione, umana troppo umana, a trovare un posto nel mondo, un senso, un amore. Alla perenne ricerca di qualcosa, ci smarriamo allora fra dune di sabbia, destinati a non giungere mai all'oasi cui aneliamo. Ma non importa, suggerisce Geoff Dyer, la vita è questo, quello che succede quando non troviamo ciò che cerchiamo.
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
L’assenza di confini di genere rende la lettura stimolante. Se inizialmente si pensa a un diario di viaggio, col procedere dei capitoli la dimensione più rilevante viene a essere il tempo: quello dei diversi momenti del giorno attraverso cui il visitatore fa esperienza di un’installazione di land art, quello che si deposita sui luoghi cancellando le tracce della funzione originale per trasformarli in enigmi alla riscoperta, quello che in un blocco statuario tiene uniti l’eternità e l’istante di un falso movimento legato all’angolazione dello sguardo. O ancora quello della singola esistenza che si crede illimitato e si scontra con la malattia, con la riduzione del campo visivo. I luoghi fisici possono risultare deludenti, da una Polinesia ormai priva della meraviglia di Gauguin alle isole Svalbard vissute come un inferno gelido e buio. Eppure si deve andare, si cercano posti nuovi perché desiderio e curiosità sono vitali e le esperienze sul cammino o a lato danno senso più della meta. Dyer è autore colto ed eclettico, passa dal diario alla fiction senza strappi, osserva e riflette, sia che guardi il paesaggio sia che si produca nell’analisi minuziosa di fotografie.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

Nooteboom e Dyer, virtuosi della frustrazione
Nooteboom e Dyer, virtuosi della frustrazione
Espansivi e frastagliati come solo i racconti di viaggio hanno il dovere di presentarsi, Cerchi infiniti di Cees Nooteboom e Sabbie bianche di Geoff Dyer sono due libri che confliggono. Tanto ordinato e apparentemente composto il primo, quanto ironico e rivoltato il secondo, che parte dal resoconto dell’ultimo giorno di un viaggio a Pechino e termina con un capitolo intitolato «Inizio»: libro reverso, come il meccanismo di un intramontabile modello Jaeger-LeCoultre – libro/orologio che tuttavia denuncia sull’istante che c’è tanta più struttura qui di quanta non se ne ricavi dal naturale criterio cronologico che stringe assieme i capitoli di Nooteboom. Che poi è una smilza antologia interamente dedicata al Giappone (ma i testi sono estratti dall’editore italiano da due libri diversi dello scrittore olandese) mentre Dyer, come al solito, affronta praticamente di tutto: dalla Polinesia alle installazioni di Land Art, dalle disavventure on the road con autostoppista evaso al racconto memorabile di un pellegrinaggio alla casa californiana di Adorno. Gli affanni irresistibili di una settimana alle isole Svalbard, una specie di supplizio di Tantalo in attesa di fantomatiche aurore boreali che non compariranno mai. Non nascondo che ciò che mi fa adorare i libri di Dyer (spilungone nato nel ’58 in una tranquilla città termale del Gloucestershire e trapiantato da qualche anno nel serraglio di Venice Beach – dal Regency a Baywatch, praticamente) è la vocazione a quella che lui definirebbe come una tuttità dell’oggetto-libro, che poi segna anche l’estensione – ambiziosa, maniacale – dei territori e dei materiali che fanno le sue pagine.
Nooteboom è un compito signore classe ’33 più volte candidato al Nobel che indossa maglioni comodi, ama guardare in basso come fanno gli introversi ma quando si anima sa gesticolare in maniera molto mediterranea. Ha frequentato con successo quasi ogni genere letterario. È un prosatore acuto, elegante, dettagliato, innocente. È bene tornare, di quando in quando, a una certa innocenza di osservatori come lui, nei quali anche l’ironia proviene da una vibrazione stupita (leggete la passeggiata sotto la pioggia in un paesino della prefettura di Nagano). Dyer appartiene – con John Berger, Phillipe Lopate e pochi altri – a una razza di talenti che sanno illuminare il mondo col solo atto di guardarlo (non è un caso che molti di loro siano soprattutto venerabili scrutatori d’immagini). Dyer, diciamolo, è esattamente il tipo di osservatore di cui ha bisogno il nostro tempo, dopodiché è anche un maledetto genio. Il tipo di inglese che porta l’intelligenza come uno stemma sulla fronte amplissima (intelligenza britannica, imperialista, incline a celebrare l’estensione del proprio dominio con la naturalezza serafica di un grosso rapace). Uno che sul paragrafo è sciolto e confidenziale, quando mette un verbo e un aggettivo dentro una frase dà sempre l’impressione di averli scoperti in quel momento esatto.
Questa freschezza degli scrittori come lui è già di per sé prolusione o addestramento a una narrativa avvincente (quella più contaminata dal personal essay). Nella medesima risma e tra qualche linea di febbre, talvolta con l’apparente, accidiosa onniscienza dei fuoriclasse: Martin Amis saggista, DFW qualsiasicosista. C’è tuttavia un che di antico nella freschezza di Dyer, come di un lessico fragrante perché non levigato dalla banalità, tonico come gli oggetti caduti in disuso e appena riscoperti (ma esiste davvero, fra gli scrittori, l’eventualità del disuso?), croccante come le lingue congetturali, frammentato e runico. Squillante, per lo più. Quanto di regola avviene nelle sue prose è una sistematica demolizione dell’innocenza, il paragrafo monta in alto non per l’avanzare delle suggestioni (Dyer saprebbe rimettere al regno della suggestione anche un paio di calzini usati, tradurre conseguenze epocali da uno starnuto) ma nella necessità di definire il proprio metodo – fino a condurre il lettore al cospetto di un’evidenza beffarda: il metodo di Dyer è nient’altro che essere Geoff Dyer, ciò che non senti, per dire, in riconosciuti maestri della proiezione mente-luogo come Lewis Mumford o Marc Fumaroli: il vivo della persona, il vivissimo, chiamiamolo così. Il Giappone di Nooteboom sta inscritto nel giusto bordo (sarà il segreto del suo equilibrio: rifilatura), gli spostamenti di Dyer ricordano piuttosto una stampa “al vivo”, come si dice nel gergo delle copisterie. La prosa occupa ogni spazio possibile senza rivestirsi di elettricità o isteria: è la prosa gassosa di chi ha abdicato a ogni simulazione d’innocenza.
In Sabbie bianche Dyer viaggia con uno specchio, sua moglie. Viaggia, o più correttamente si sposta. Adesso “spostarsi” è un omaggio apparecchiato ad hoc per il cultore di lettere italiano: vorrebbe riflettere il retroscena nevrotico di pellegrini riottosi e prolifici, squartierati e grondanti come Manganelli. L’artificio conclamato in Sabbie bianche è quello di omettere il vero nome della moglie e utilizzarne uno d’invenzione. Basta questo a suscitare un Altrove, come negli universi paralleli della fantascienza: sfasati di poche frequenze, o anche di una sola virgola rispetto al nostro – è l’oscura funzione-Borges che opera in Dyer, sempre con l’opacità di una variante sorniona, di un presupposto scontato. In Nooteboom il presupposto dell’osservatore è invece una certa apprensione. Alleva il primo dei suoi scritti e da lì scivola in tutti i testi che lo seguono, anche a distanza di molti anni, il che è decisamente bello, nel senso che è bello assistere alla persistenza di uno stato d’animo man mano che il viaggiatore familiarizza e penetra nei luoghi (Tokyo, Nara, Osaka, Kobe accarezzata magistralmente da una prospettiva portuale, ecc.): ci conferma che l’apprensione è un’eccitazione spoglia, il residuo di palpiti sfumati (nell’esperienza? nel dubbio? nelle riserve?) – e in ogni caso ci predispone di nuovo all’esercizio del conflitto, perché le cose che vediamo si accalcano su un “prima”, mentre il libro di Dyer poggia quasi sempre su un “dopo”, non raccontando altro che l’esperienza del rammarico: luoghi che sono paurosamente diversi da quello che si sperava, luoghi che non mantengono mai le promesse (ma i luoghi non promettono un bel niente, come potrebbero? i luoghi stanno là, e viaggiare è soprattutto andare là).
Volendo tentare un accomodamento fra i due libri si potrebbe dire che il denominatore comune del viaggiare (non l’esito, ma diciamo una zona di competenze condivise) sia la frustrazione. Paradosso segnaletico: non esiste concetto più lontano da questi libri dello stare comodi, a parte per lo stile. Paradosso annidato nel paradosso: lo stare comodi è insieme la realizzazione del viaggio (il viaggio totalmente amministrato, un Moloch heideggeriano) e la sua negazione suprema, ciò che si chiama il viaggio di lusso (le suite del Burj al-Arab, i vani opulenti di prima classe nei nuovi Airbus, cosa rappresentano se non la replica e l’ottimizzazione del comfort domestico? La casa in trasferta, proporzionata alle sovrumane capacità di spesa di chi può permettersi di spostarsi in quel modo).
Pertanto viaggiare dev’essere un’esperienza frustrante, altrimenti non è viaggiare. Si viaggia, ormai, per verificare l’esistenza dei luoghi (è il primo afflato conoscitivo, credo, o l’ultimo?). E la verifica – come Nooteboom avverte qua e là, e Dyer dichiara quasi ovunque – è subordinata a un sentimento di delusione. I posti, i tratti salienti del viaggio, la stessa saggezza che si accumula dentro i giorni: essi devono deluderci. Questo in parte ci richiama a una mitologia dell’esperienza remota, alla visione primitiva del territorio inospitale, della regione impervia da conquistarsi con le unghie. Capisco perché alcuni scrittori anche molto diversi vogliano infine scrivere dei loro viaggi. Di fatto non conosco, per la nausea che mi provocano, territori meno ospitali della lingua, regioni più impervie della pagina.
Recensione di Fabrizio Patriarca.
L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafetyibs@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri