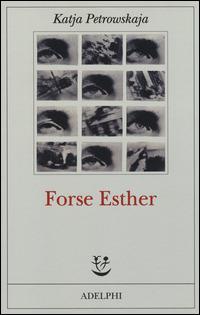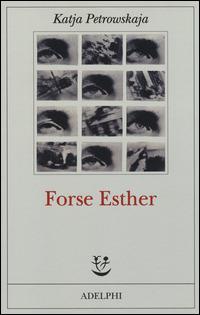L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Forse Esther
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori

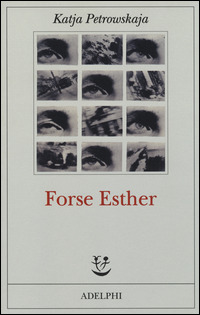
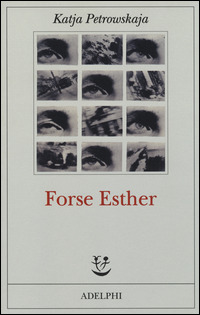
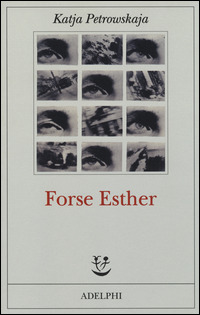
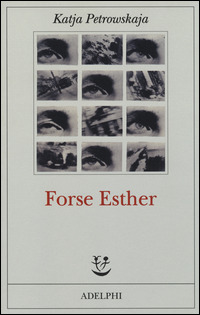
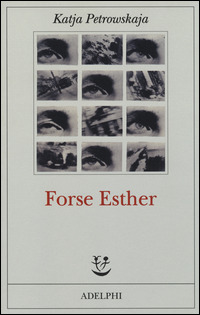
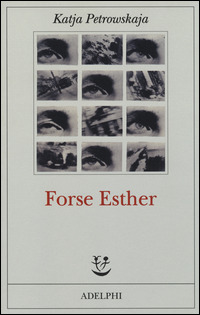
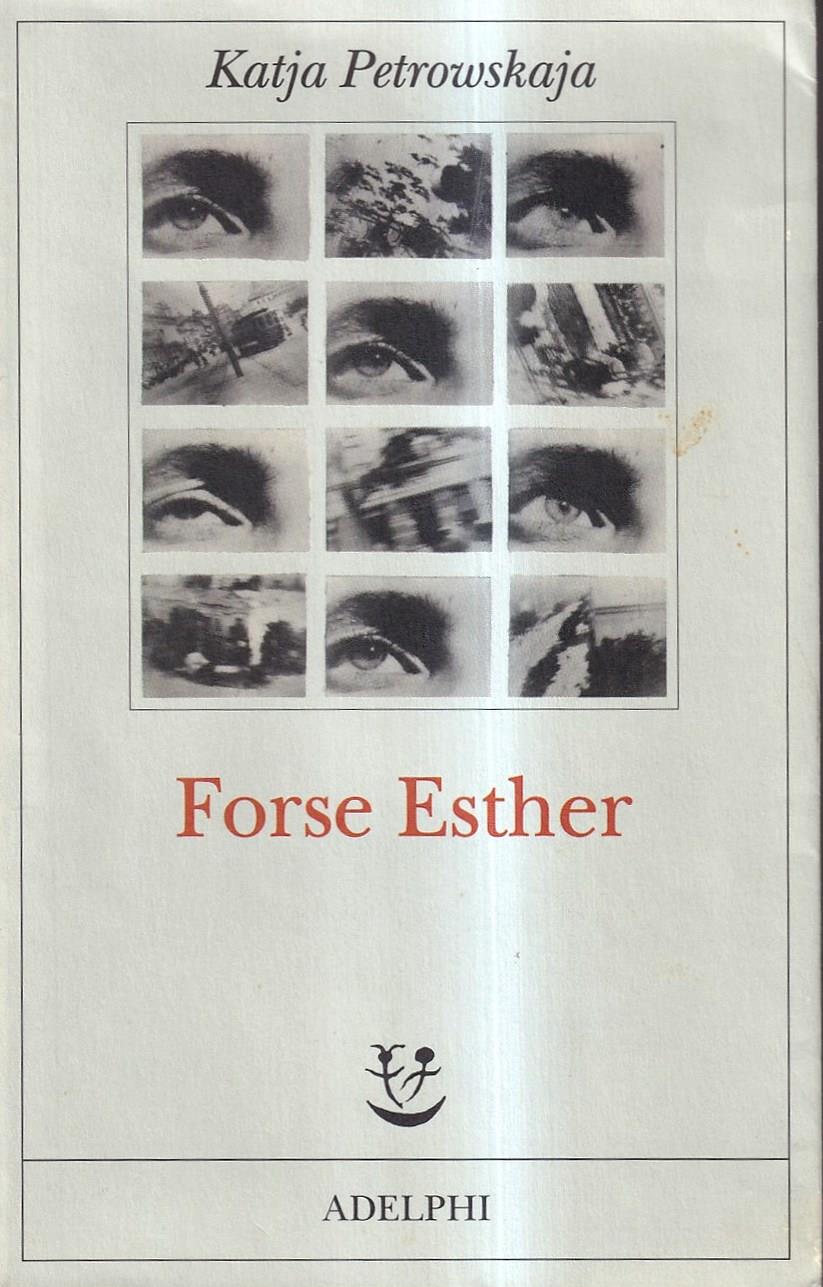
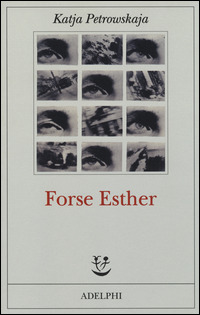
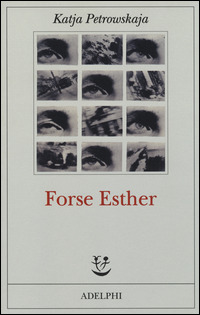
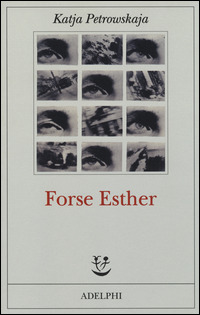
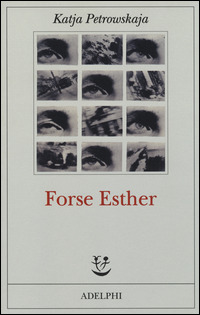
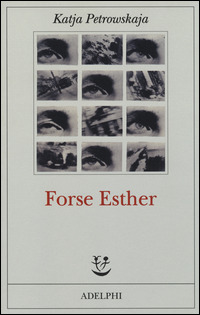
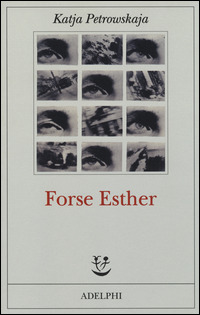
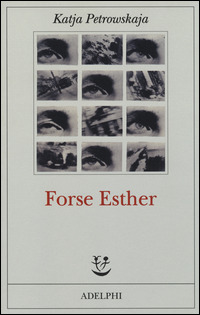
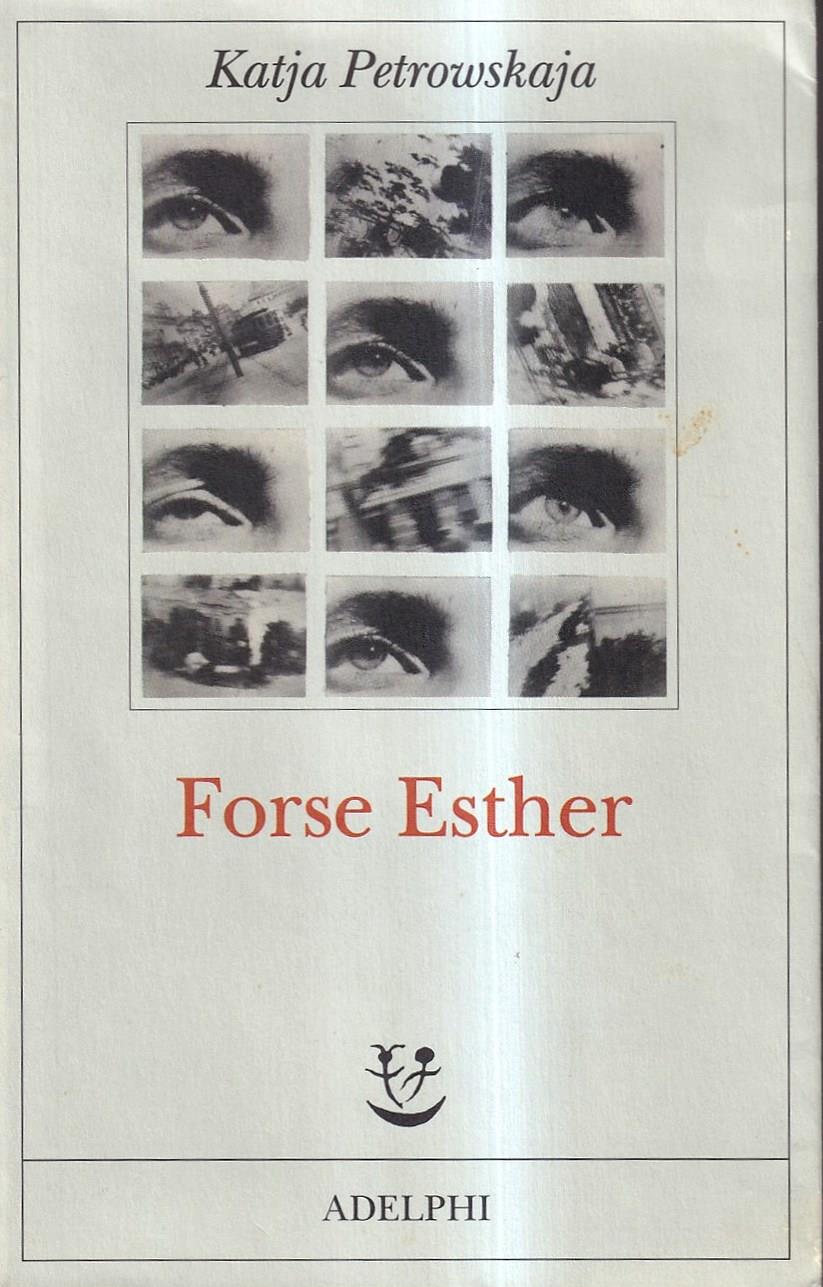
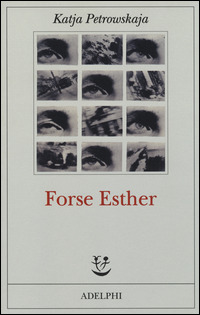
Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2014

Anno edizione: 2014

Anno edizione: 2023
Vincitore Premio Strega Europeo 2015
Si sarà proprio chiamata Esther quella bisnonna che, nella Kiev del 1941, chiese fiduciosa a due soldati tedeschi la strada per Babij Jar, la fossa comune degli ebrei, ricevendone come risposta un distratta rivoltellata? Forse. E dell'intera famiglia, dispersa fra Polonia, Russia e Austria, che cosa ne è stato? Il monolite sovietico conosceva l'avvenire, non la memoria. Per ricostruire quella ramificata genealogia, quel vivace intreccio di culture e di lingue - yiddish, polacco, ucraino, ebraico, russo, tedesco -, Katja Petrowskaja intraprende, sulle tracce degli scomparsi, un intenso viaggio a ritroso nella storia di un Novecento sul quale incombono la stella gialla e quella rossa, e in cui si incrociano i destini di memorabili figure: la babuska Rosa, incantevole logopedista di Varsavia, che salva duecento bambini sopravvissuti all'assedio di Leningrado; il nonno ucraino, prigioniero di guerra a Mauthausen e riemerso da un gulag dopo decenni; il prozio Judas Stern, che spara a un diplomatico tedesco nella Mosca del 1932, e dopo un processo-farsa viene spedito "nel mondo della materia disorganizzata"; il fratello Semén, il rivoluzionario di Odessa, che passando ai bolscevichi cambia in Petrovskij un cognome troppo ebraico... Ma indimenticabili protagonisti sono anche i paesaggi: l'immane pianura russa invasa dai tedeschi e le città della vecchia Europa: Kiev, Mosca, Varsavia, Berlino. E i ghetti, i gulag e i lager nazisti.
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Mi è piaciuto molto. Mi è sembrato di essere accanto alla scrittrice nelle sue ricerche di storie e di persone della sua famiglia. Aprendomi un mondo che non conoscevo, tra Mitteleuropa e URSS
Mi aspettavo di più. La casa editrice e la tematica per me sono una garanzia, in genere. Qui invece c’è stato un problema; troppo autoreferenziale. L’autrice si mette al centro di eventi storici che non ha vissuto personalmente. Forse sarebbe stato meglio lasciare maggior spazio agli altri personaggi che hanno vissuto la Storia sulla loro pelle.
Scrittura che non decolla. Discontinuità che non riesce a coinvolgere.Come direbbero a scuola: apprezzabile solo per l'impegno.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafetyibs@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
Siamo spiacenti si è verificato un errore imprevisto, la preghiamo di riprovare.
Verrai avvisato via email sulle novità di Nome Autore