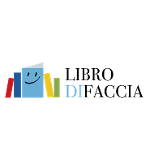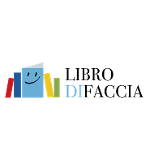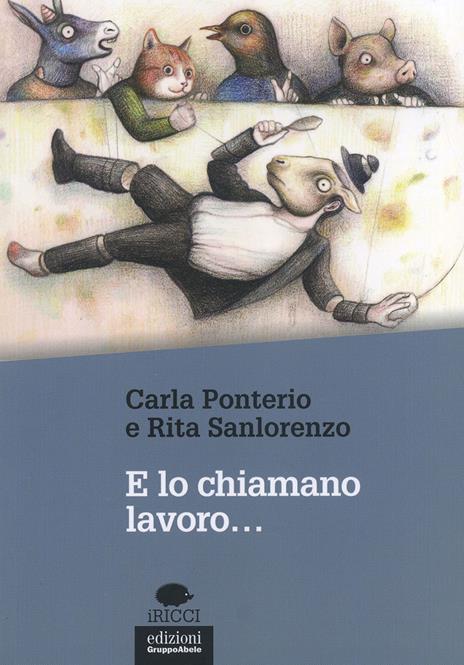E lo chiamano lavoro
è il racconto della parabola disegnata da quell'attività umana che la Costituzione del 1948 ha elevato a fondamento della repubblica e che ha rappresentato per l'ordinamento giuridico l'oggetto della promessa più ardua da mantenere: quella scritta nell'articolo 3. Il volume, che non è una storia repubblicana del lavoro tout court, rappresenta invece la condivisione di una memoria particolare, quella autrici, le quali, per mestiere, risolvono i conflitti dell'ambito dei rapporti di lavoro, interpretando ogni giorno la legge. Con un approccio sintetico ma non impreciso, i due giudici del lavoro offrono uno spaccato degli snodi che hanno via via mutato i rapporti di forza fra capitale e lavoro. La narrazione comincia con l'emanazione della Costituzione che, ricordano le autrici, tutela sì tutti i tipi di lavoro (articolo 35), ma non esita a riconoscere solo ai "salariati sotto padrone" diritti e aspettative che avrebbero dovuto concretizzarsi attraverso la legislazione e l'azione amministrativa. Si ripercorre quindi il periodo di espansione economica, il conflitto permanente e l'ingresso della Costituzione nelle fabbriche con l'approvazione non unanime dello Statuto dei lavoratori. Poi si descrive l'evoluzione della nuova magistratura (sempre più giovane e meno maschile e conservatrice) e si racconta dell'istituzione del rito del lavoro e delle caratteristiche del giudice che deve applicarlo: un giudice finalmente protagonista del processo, e non solo arbitro, capace di comprendere la realtà grazie ai nuovi strumenti "speciali" messi a sua disposizione. Forse, si calca un po' la penna quando si dice che la riforma del 1973 vuole un giudice che abbia la "tensione ideale per realizzare (
) l'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini". Quella tensione ideale, infatti, è tutta nelle leggi di allora e si deve esprimere anche per il tramite di giudici meno sensibili delle autrici. Peraltro, questo genere di evoluzione funzionale (che induce l'operatore del diritto a prestare maggiore attenzione ai fatti e alla concretezza più che ai formalismi e ai concetti astratti) non caratterizza solo la storia del diritto del lavoro italiano e dei giudici del lavoro, ma è uno dei sintomi più qualificanti della storia di tutto il novecento giuridico. Sulla sfaccettata vicenda dei così detti pretori d'assalto, si tende a non riconoscere alcuni eccessi del passato e a denunciare semmai la persistenza, allora, di incrostazioni conservatrici. La parabola ascendente del lavoro finisce qui: nel bel mezzo degli anni settanta. Segue la storia della crisi della classe operaia e del tradimento delle promesse di tutela: una storia fatta di resistenze padronali e politiche al completamento del programma costituzionale, di insofferenza per le "rigidità" dello Statuto dei lavoratori, ma anche di coinvolgimento politico dei sindacati (tramite la concertazione), di terrorismo che avvelena, da fuori, le relazioni sindacali, di incomunicabilità fra operai e quadri (la marcia dei quarantamila). Un capitolo che si chiude con la prima critica ai sindacati e alla politica di allora, per il tentativo ambiguo di limitare (anche loro) il ruolo del giudice del lavoro: per le autrici, la pretesa delle parti sociali di "far da sé nella ricerca della regola è un abbaglio" che ha colpito sindacati e imprenditori. Affiora così la concezione profonda del ruolo del giudice del lavoro: quest'ultimo viene raffigurato non solo come il protagonista del processo, ma anche come attore in campo delle relazioni industriali. È una visione radicale della funzione giurisdizionale, ma solo nel senso di un approccio convintamente democratico e costituzionalmente orientato: infatti, piaccia o no, una traccia di questa narrazione poggia anche sulla nostra Carta costituzionale. Comunque sia, le sfaccettature del periodo avrebbero forse giustificato una rilettura più critica di alcuni eventi e del ruolo dei giudici, ma il rinvio alla riedizione dell'autorevole contributo di Giorgio Ghezzi del 1981 (Processo al sindacato, Una svolta nelle relazioni industriali: i 61 licenziamenti Fiat, pp. 176, 12, Ediesse, Roma 2012) è un rimedio sufficiente, in particolare per poter sfogliare le due interessanti rivisitazioni di Andrea Lassandari e Federico Martelloni. Si prosegue, poi, con un riepilogo delle nuove suggestioni e della retorica della flessibilità, che non si fondano su dati empirici e che trovano la strada spianata nel dissolvimento della classe operaia e nel superamento del fordismo; si giunge rapidamente alle politiche dei governi di centrosinistra e di centrodestra, ai rigurgiti di terrorismo a cavallo del 2000 e si approda, infine, ai giorni nostri, con la riforma Fornero e il jobs act, duramente criticati anche per la fattura legislativa. Per un verso, nel volume ci si chiede come mai si pensa che il modo per rallentare la crisi economica possa essere quello di allentare le difese che avevano in passato reso possibile la crescita collettiva della società; o ancora si dà atto che "la flessibilità del lavoro nel nostro sistema ha esclusivamente un dato di interesse per gli imprenditori, consistente nella riduzione del costo del lavoro" e che il lavoro precario rappresenta un ponte verso l'impiego stabile solo nel 12 per cento dei casi. D'altro canto, però, si afferma anche che "la sfida oggi è quella di cambiare lo strumentario [lo Statuto dei lavoratori] ma per perseguire lo stesso obiettivo [costituzionale]"; si riconosce che non bisognerebbe solo combattere le forme di lavoro atipico fasulle, ma tutelare con appositi statuti anche i lavoratori autonomi genuini e approntare le misure che richiede una prospettiva di normale mobilità all'interno del mercato del lavoro (forse secondo la stessa logica di una flexicurity buona?); si ammette, infine, che il dibattito sull'articolo 18 ha un valore ideologico, ma poi si afferma che la riforma Fornero "punta dritto al cuore della civiltà del diritto del lavoro e dunque alla norma che difende il lavoratore dal licenziamento ingiustificato". Questo intreccio di piani contradditori, ma tutti condivisibili, è la cartina di tornasole della conclusione più amara che si legge nel volume: "non c'è più un codice giuridico del lavoro, ma soprattutto non c'è un codice morale capace di tradursi in politica". Il disorientamento degli addetti ai lavori è in effetti conclamato, ma esistono tentativi di aggiornare i vecchi istituti alla luce delle nuove condizioni del mercato e della produzione (per fare solo un paio di esempi: Matteo Borzaga, Lavorare per progetti. Uno studio su contratti di lavoro e nuove forme organizzative d'impresa, pp. 328, 29, Cedam, Padova 2012e Massimo Pallini Il lavoro economicamente dipendente, pp. 246, 22,50, Cedam, Padova 2013). Ponterio e Sanlorenzo, infine, non si limitano ad esprimere un nostalgico amarcord, ma provano a scrutare orizzonti futuri da cui trarre nuovi paradigmi. Vengono rilanciate, così, proposte audaci di politica del diritto (una rifondazione costituzionale europea) e viene promossa la riflessione, oggi alla moda, sui beni comuni, fra i quali può annoverarsi la conoscenza, nuovo mezzo di produzione per fortuna inalienabile. Nulla si dice però a proposito dell'opportunità o meno di riformare anche il settore della giustizia italiana. Questo approccio innovativo, tutto da approfondire, non impedisce però alle due autrici di auspicare un ritorno al paradigma della classe sociale, a cui si può ancora appartenere non più in ragione del tipo di lavoro prestato, ma in quanto ognuno scelga di coltivare relazioni nel mercato della conoscenza, che produce ricchezza e contrasta l'isolamento. Maurizio Falsone
Leggi di più
Leggi di meno