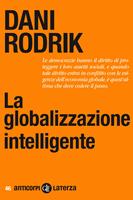L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
La globalizzazione intelligente
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Altre offerte vendute e spedite dai nostri venditori





Promo attive (0)
"La straordinaria diversità che caratterizza il nostro mondo attuale rende l'iperglobalizzazione incompatibile con la democrazia. Una base esigua di regole internazionali che lascino sufficiente spazio di manovra ai governi nazionali rappresenterebbe una globalizzazione migliore poiché potrebbe correggere i mali caratteristici della globalizzazione e nello stesso tempo mantenere i suoi essenziali vantaggi economici. Abbiamo necessità di una globalizzazione intelligente più che di raggiungere i livelli massimi di globalizzazione": Dani Rodrik ripercorre la storia dell'economia per dimostrare come il problema non sia tanto la globalizzazione, quanto il modo di interpretarla e governarla. Possiamo e dobbiamo procedere a un tipo di narrazione differente relativa al processo di globalizzazione. Invece di considerarla un sistema che esige un'unica serie di istituzioni oppure una superpotenza economica principale, dovremmo accettare di considerare la globalizzazione come l'unione di nazioni, le interazioni tra le quali sono regolate solo da poche leggi semplici, trasparenti e di buon senso riguardanti le attività commerciali. Questo modo di vedere le cose non costruirà un percorso che conduce verso un mondo "rigido". Niente di tutto questo. Grazie a tale modo di vedere sarà possibile costruire un'economia mondiale sana e sostenibile nell'ambito della quale verrà lasciato spazio alle democrazie per determinare a proprio piacimento il loro futuro.

Docente di Harvard, Dani Rodrik è uno dei più importanti economisti dello sviluppo al mondo, e forse il più originale tra i nuovi pensatori della globalizzazione. I suoi studi sono stati pubblicati dalle più prestigiose riviste internazionali di economia, i suoi editoriali da quotidiani come il "Financial Times" e sono tra i più letti del portale Project syndicate e i suoi volumi hanno ottenuto ampio successo in America e nel resto del mondo, Italia esclusa. Quello pubblicato da Laterza è infatti il primo libro di Rodrik tradotto in italiano; il più importante, poiché trae ispirazione dall'intero corpus di ricerche dell'autore, che trovano qui una sintesi ragionata, indispensabile per chi non abbia avuto la fortuna di leggere i saggi in lingua originale. E di fortuna davvero si tratta. Non è solo per il titolo difficile comprendere per quali motivi "Il paradosso della globalizzazione. La democrazia e il futuro dell'economia mondiale" sia stato sacrificato per il poco saporito La globalizzazione intelligente ma per l'intero lavoro di traduzione. La fama di Rodrik è anche dovuta, come spiega l'autore, all'editore del suo primo volume (Has Globalization Gone Too Far?, 1997), quell'Institute for International Economics spesso veicolo dei messaggi dell'economia mainstream: John Williamson, l'ideatore, per così dire, del "Washington Consensus", è uno dei suoi senior fellows. Rodrik vorrebbe invece offrire al mondo un'altra storia, un altro racconto della globalizzazione, ancora oggi indissolubilmente associata ai dettami dell'integrationist agenda degli anni novanta. Peccato quindi che nella traduzione italiana, si traduca "narrative" con "esposizione" (che ne direbbe Lyotard?): uno dei principali meriti di Rodrik è quello di aver riportato prepotentemente alla ribalta, rispetto ai suoi avversari, la dimensione storica (sulla scia dei Cattivi samaritani di Ha-Joon Chang, Bocconi, 2008; cfr. "L'Indice", 2009, n. 11).
Ma questo è niente. La nostalgia di Rodrik per il regime di Bretton Woods si fonda sul concetto di "embedded liberalism" libero scambio e multilateralismo, ma nel rispetto del policy space delle singole nazioni , utilizzato da John Ruggie nel lontano 1982, con esplicito richiamo al Polanyi di La grande trasformazione. Nel testo italiano, si discute del "liberalismo incorporato" e talvolta di quello "radicato", come se davvero le espressioni significassero qualcosa. Ma questo è ancora poco. Stupiscono il "sistema aurifero" anziché aureo, e le "aspirazioni appagate" che traducono self-fulfilling expectations (aspettative che si autorealizzano). Chiunque abbia letto un testo di economia sa che le "rational expectations" sono aspettative, e non previsioni, razionali; e che le "positive externalities" non hanno nulla a che vedere con "apparenze positive" (!). Materiale per Rodari: "second-best world"? "Mondo di seconda categoria". "Business as usual"? "Attività commerciali come di consueto". Pagina 145: i "populists" sono "persone affette da demagogia"; la "industry" della finanza diviene "settore industriale"; i "mainstream economists", "conformisti". Chissà quei poveri argentini alle prese con la crisi del 2001, nella consapevolezza non di aver perduto un decennio (il famoso "lost decade" dei novanta, e del Washington Consensus), ma di averne vissuto uno "di disorientamento"
Il peggio deve ancora venire: immaginiamo lo sconcerto del lettore nell'apprendere che "tale livellamento globale delle politiche era inaccettabile da Keynes (largamente condivisa sic da altri ideatori del regime di Bretton Woods) la cui visione era che l'economia nazionale e gli obiettivi di natura sociale dovevano essere prima sic e sigh dell'economia globale". Si accorgerà il lettore che "relaxing the restrictions" è stato tradotto "porre limiti alle limitazioni", rovesciando l'argomentazione di Rodrik? Che "squeezing large gains from the world trade regime" non vuol dire "comprimere gli elevati profitti derivanti da
" ma anche qui, il senso è l'opposto "estrarre elevati profitti da
"?
Ci fermiamo qui, ma errori concettuali di questo tipo ricorrono ogni due pagine: il lettore alla ricerca di una nuova narrazione della globalizzazione sarà dunque costretto a imparare l'inglese. Nelle recensioni apparse su autorevoli riviste e testate nessuno ha insistito sull'illeggibilità della traduzione italiana; forse i recensori conoscevano per via diretta le analisi di Rodrik, e di quelle anno scritto. Faremo come loro, ma dichiarandolo. The Globalization Paradox (W. W. Norton & Company, London-New York 2011) è un libro che segnerà la nostra era. Nel tentativo di comprendere a cosa serve la globalizzazione, a partire dalla nozione dei costi di transazione connessi al libero scambio, vista in prospettiva storica, Rodrik rovescia la prospettiva: quando tutti si dedicano allo studio delle possibili modalità per ridurre il conflitto alimentato dalle esigenze degli stati nazionali con l'obiettivo ultimo di un mondo perfettamente integrato, Rodrik propone soluzioni concrete (si veda il suo piano per un'equa distribuzione dei benefici che è possibile trarre dai flussi migratori di manodopera) per moderare l'impatto negativo della globalizzazione sul policy space nazionale, e cioè sulla possibilità per ogni stato-nazione di definire autonomamente la propria via allo sviluppo e al benessere.
La globalizzazione serve agli stati nazionali, imprescindibili attori di una scena globale che non troverà a breve (o medio, e forse lungo) termine un governo federale mondiale in grado di perseguire l'obiettivo di una crescita economica rispettosa dell'eterogeneità (di preferenze, obiettivi, percorsi storici) che caratterizza la scena stessa. Una globalizzazione che si imponga comprimendo il policy space nazionale (secondo il modello della "camicia di forza dorata" argentina del decennio perduto) serve solo ai soliti interessi finanziari, politici e industriali sui quali l'autore sorvola. Scelta comprensibile, è semplicemente troppo importante insistere sull'assurdità di raccontare la globalizzazione come se fosse un fine indiscutibile e senza nemmeno rilevare si veda l'istruttiva disamina del percorso delle negoziazioni commerciali dalla creazione della Wto fino al Doha Round quanto siano esigui i vantaggi che otterremmo dal perseguire l'agenda integrazionistica. Del resto, gli attuali campioni della globalizzazione sono le vittime (reali o potenziali) del Washington Consensus, quegli stati che, con l'intento di sfruttarla il più possibile, le hanno resistito, Cina (memore della crisi asiatica del '97) in primis. E a soffrire della crisi sono i paesi del Consensus stesso, che nell'imporre la libera circolazione dei capitali perché così deve essere, hanno finito con il dimenticare che è proprio nella finanza libera che le crisi, storicamente, hanno trovato un potente alleato.
Nel recuperare per l'oggi l'essenza del compromesso di Bretton Woods, Rodrik è l'ideale continuatore del Keynes che poneva la varietà tra i fini ultimi dell'etica, e difendeva l'accordo del 1944 proprio perché evitava di interferire con la "diversity of national policy". Libero scambio? Sì, ma ciascun paese resta libero di imporre restrizioni che non mirino a proteggere l'industria nazionale, ma a salvaguardare gli accordi sul lavoro, la protezione della salute, dell'ambiente (mascherare il protezionismo è difficile, se nel paese che adotta simili restrizioni gli scontenti sono in grado di farsi sentire). Finanza libera? No, perché diverrebbe impossibile accontentare le inconciliabili preferenze di normativa e regolamentazione tra i diversi stati-nazione. Cina: che persegua pure le sue legittime strategie di crescita graduale fondata sulle esportazioni, ma il resto del mondo sia libero di limitare gli effetti negativi che da una simile strategia derivano all'esterno.
Vi sono alternative praticabili? Certo, quelle che hanno condotto alla crisi prima i paesi in via di sviluppo, poi i campioni del Washington Consensus, e infine l'Occidente stesso. Il guaio è che, avendo accettato di sacrificare il policy space sull'altare dell'iperglobalizzazione, non siamo in grado di immaginare altro che un impraticabile governo universale da parte di istituzioni illuminate dall'obiettivo ultimo e capaci di convincere gli stati-nazione della sua bontà. Ma contrariamente a quello che siamo giunti a pensare, spiega Rodrik con rarissimo buon senso, il libero scambio deve essere valutato per i benefici che comporta per il singolo stato-nazione. Un nuovo ordine internazionale non può che fondarsi sul diritto alla differenza, sul diritto, direbbe Chang, di sbagliarsi; l'unica globalizzazione possibile è quella che non reprime ma, anzi, potenzia la libertà di scelta. Il pragmatismo postmoderno di Rodrik è quanto di meglio abbiamo a disposizione per andare avanti, dopo esserci guardati indietro.
Mario Cedrini
L'articolo è stato aggiunto al carrello
Le schede prodotto sono aggiornate in conformità al Regolamento UE 988/2023. Laddove ci fossero taluni dati non disponibili per ragioni indipendenti da IBS, vi informiamo che stiamo compiendo ogni ragionevole sforzo per inserirli. Vi invitiamo a controllare periodicamente il sito www.ibs.it per eventuali novità e aggiornamenti.
Per le vendite di prodotti da terze parti, ciascun venditore si assume la piena e diretta responsabilità per la commercializzazione del prodotto e per la sua conformità al Regolamento UE 988/2023, nonché alle normative nazionali ed europee vigenti.
Per informazioni sulla sicurezza dei prodotti, contattare productsafetyibs@feltrinelli.it
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri